

1 marzo 1896
La battaglia di Adua fu il momento culminante e decisivo della guerra di Abissinia tra le forze italiane e l'esercito abissino. Gli italiani subirono una pesante sconfitta che pose fine alle ambizioni coloniali sul corno d'Africa. La sconfitta ad Adua non avvenne per caso. All'errore fondamentale di sottovalutare l'avversario, si aggiunsero le decisioni sbagliate assunte nel corso degli eventi.
A cura di Giuseppe Bufardeci
ADUA
Ho lavorato tre anni in Etiopia (1988-90 e 1995-96) e ne ho un ricordo bellissimo, sia del paese, una vera perla da un punto di vista naturalistico e storico, sia, soprattutto, degli abitanti, un misto di primitività e antichissima nobiltà.
Il primo marzo in Etiopia è festa nazionale. Quel giorno non mi ero informato di quale ricorrenza si trattasse, ma mi sorpresi che tutti coloro che incontravo e mi conoscevano, si prendessero bonariamente, ma anche orgogliosamente, un po’ gioco di me. Quando mi misero al corrente della commemorazione, l’anniversario della vittoria sugli italiani nella battaglia di Adua avvenuta nel 1896, confesso che avvertii una strana sensazione. Noi italiani, oltre avere rimosso l’evento dalla memoria, libri di storia a parte, abbiamo sempre e solo parlato di sconfitta di Adua, ma adesso per me era chiaro, anche se lapalissiano, che se qualcuno aveva perso evidentemente qualcun altro aveva vinto e a quanto pareva se ne ricordava ancora bene. Quindi mi rassegnai ogni primo marzo in Etiopia, a “subire” dai miei magnifici padroni di casa qualche presa in giro.
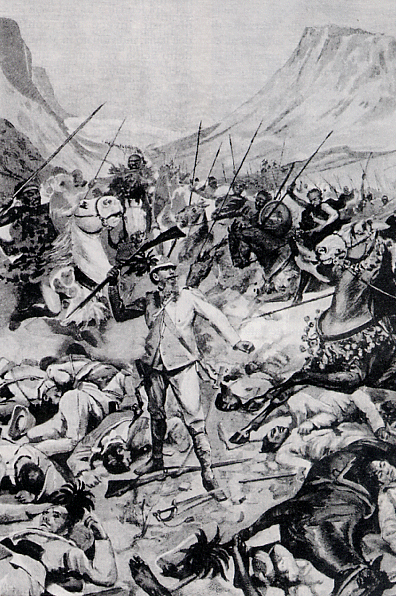
Come di consueto per questo scritto la fonte principale è un libro che, secondo me, descrive bene come si svolsero i fatti e da cui ho estrapolato lunghi stralci, legandoli tra loro.
Si tratta di Adua di Domenico Quirico, Oscar Storia Mondadori, 2005.
Altre fonti sono state:
1)Battaglia di Adua (Abba Garima) di Piero Pastoretto;
2)Adua - I perchè di una sconfitta di Giuseppe Governale (www.carabinieri.it);
3)Wikipedia;
4)Treccani.
Giuseppe Bufardeci
ADUA

Generale e politico, nel 1860 si unì ai Mille di Garibaldi, rimanendo con le camicie rosse fino al 1866. Nel 1867 prese parte alla battaglia di Mentana, nel 1872 su arruolò nel regio esercito. Divenne colonnello nel 1886. Partecipò come colonnello dei bersaglieri a diverse campagne militari in Eritrea nel 1887, 1890 e 1892. Fu eletto deputato per la destra storica per sei legislature. Designato nel 1891 comandante in capo delle truppe italiane in Africa, nel 1892 fu nominato governatore della colonia Eritrea e comandante in capo delle truppe coloniali col grado di maggior generale. Dopo che, il 21 dicembre 1893, il colonnello Arimondi aveva sconfitto i dervisci1 ad Agordat, attaccò improvvisamente Cassala, nel Sudan, vicino al confine, sostenendo di dover prevenire una massiccia offensiva derviscia attesa per l'autunno. Occupò facilmente Cassala, ma l'impresa rimase sterile di risultati. La campagna militare fu esageratamente glorificata in Italia, e a Baratieri fu conferita la croce di commendatore dell'Ordine militare di Savoia. Dopo Cassala, la situazione andò precipitando verso la guerra, dapprima limitata a spedizioni contro i ras dei territori confinanti con la parte di Eritrea occupata dagli Italiani, poi contro tutto l'Impero etiopico. L'inizio della campagna nel Tigrè, contro le forze di ras Mangascià, che era il signore della regione, fu favorevole a Baratieri: egli riportò alcune vittorie non decisive a Coatit (13-14 gennaio 1895) e a Senafè (15 gennaio 1895), le quali aprirono tuttavia alle forze italiane la via dell'interno. Baratieri, sperando di cogliere l'occasione favorevole per ampliare la colonia Eritrea, passava nel marzo il confine e procedeva all'occupazione di Adigrat, Macallè, Adua e Axum. Tuttavia, dopo Coatit e Senafè Baratieri aveva perso tempo prezioso per risolvere, in senso difensivo o in senso offensivo, la situazione a suo vantaggio. Dopo l'occupazione di Adua, poi, il governo italiano, che aveva acconsentito, se non desiderato, che Baratieri superasse i confini della colonia, insisteva per ragioni di politica interna, dovute al contrasto che opponeva le aspirazioni africane di Crispi alla politica di economie del ministro Sonnino2, perché Adigrat restasse l'estrema propaggine della colonia e venisse pertanto evacuata Adua.
Il problema è che Oreste Baratieri non era un soldato di professione, ma occasionale. Era innanzitutto un garibaldino. E questo in un’Italia in cui il mito risorgimentale si era ben cementato voleva dire molto. Una camicia rossa nell’armadio era un’ottima patente per una buona carriera. Essere stato uno dei Mille contava eccome e Baratieri a 18 anni lo era stato. In più essere nato in provincia di Trento, e cioè un irredento, aggiungeva un ulteriore merito.
Nel 1872 una legge aveva trasformato un garibaldino senza studi bellici, senza accademie e cognizioni strategiche in ufficiale regolare, “per meriti storici” si direbbe oggi. Egli, inoltre, si era portato dietro un’altra dote molto italica, un rosa di amici potenti con cui aveva marciato da Marsala al Volturno: Crispi, Zanardelli e Nicotera, tutti poi diventati importanti uomini politici. Ma una divisa e una promozione non bastano a essere trasformati in un militare ed, infatti, Baratieri, che si era anche lui buttato in politica, era più a suo agio tra i corridoi di Montecitorio che tra le truppe.
Da governatore dell’Eritrea, su incitamento di Crispi, incomincia la penetrazione in Abissinia, non senza qualche difficoltà, soprattutto di bilancio. Il governo di Roma gli lesina i soldi, la colonia deve badare a sé stessa. Presenta le dimissioni, probabilmente con la certezza che vengano respinte ed infatti così è. Crispi privatamente gli scrive: “Trova tu il modo di sciogliere il problema con i mezzi che ti offre il paese. Napoleone faceva la guerra con il denaro dei vinti”.
Baratieri, nell’estate del 1895, si reca in Italia, trionfalmente accolto, ma non ottiene nulla di concreto, salvo l’arruolamento di 1.000 soldati indigeni e 700 quadrupedi. Gli vengono promessi al massimo 9.000.000 di lire, non di più, pena la bancarotta dello stato e per le truppe nazionali si vedrà. Il governo gli ribadisce due concetti chiari, ma inconciliabili: questione finanziaria, non si spende più una lira e successo obbligatorio dinanzi al Parlamento e alla nazione. “Non temere nulla” gli dice Crispi, “io sono fortunato e sotto di me anche in Africa tutto deve andare bene3”.
Un piccolo scontro vittorioso nel Tigré crea l’illusione di una futura facile vittoria. Baratieri telegrafa che non gli servono più i rinforzi, ma il 9 dicembre il disastro dell’Amba Alagi, frutto poi del pasticcio e dell’antipatia e disaccordo tra Baratieri e il suo vice, il generale Arimondi, rimette tutto in discussione. Invece di investigare sulla sconfitta e compattarsi contro il nemico, tutto viene insabbiato nella retorica dell’eroismo. Intanto più di 100.000 etiopi marciavano verso la colonia decisi a buttarci in mare.
Baratieri ne è annichilito, telegrafa che gli servono rinforzi, li riceve, ma non è contento, dice che non sono soldati adatti all’Africa, inoltre mancano i muli e i cammelli per le salmerie.
A Roma, col nemico alle porte, anche se incominciano ad intuire che il governatore non è un Napoleone coloniale, pensano che cacciarlo ora sarebbe un disastro maggiore. Allora si opta per la soluzione peggiore, tenere la situazione sotto controllo direttamente da Roma con i telegrammi e così ci si avvia verso un altro pasticcio ed una sconfitta.
Nei capitoli a venire vedremo poi l’epilogo della carriera di Baratieri dopo la disfatta.

Imperatore d’Etiopia, Leone della tribù di Giuda, Negus neghesti (Re dei re), il prediletto di Dio. Sahle Mariàm, il futuro Menelik II era un uomo prudente, intelligente ed astuto. Non si diventa imperatore d’Etiopia se non si posseggono queste qualità. L’Etiopia non era solo un posto difficile per fare il re, ma era un posto difficile per sopravvivere.
Già restare in vita durante e dopo il parto era un’impresa. La medicina, l’agricoltura, le infrastrutture erano come da noi ai tempi dei Longobardi.
Figlio del re (ras) dello Shoa (una regione dell’altopiano etiope), il padre pur da feudatario, al fine di mantenere una relativa indipendenza del suo regno dal feroce negus Teodoro, ancora bambino lo cede come ostaggio alla corte del negus, che, però gli si affeziona.
Menelik, anni dopo, mandato da Teodoro a domare una rivolta nello Shoa, invece ci rimane, riprendendo possesso delle terre del padre. Il negus Teodoro nel frattempo entrato in conflitto con gli inglesi, viene sconfitto e si suicida. Menelik consolida il suo regno ed inizia una politica di alleanze con le popolazioni limitrofe, i galla e gli egiziani, al tempo padroni del Sudan. Sposa nel 1883 Taitù Batùl4, figlia del ras del Semien.
Riuscì a salvare il suo regno dalla conquista del nuovo negus Giovanni IV pur facendo atto di sottomissione. Approfitta poi nel 1889 della morte di Giovanni IV, sconfitto in battaglia dai dervisci sudanesi (oggi si definirebbero dei fondamentalisti islamici africani) per rafforzare ulteriormente il suo potere regionale unendo al suo regno i territori del Tigré e dell’Amara e diventando imperatore d’Etiopia.
Fonda la capitale dell’impero, Addis Abeba (Nuovo Fiore).
Capisce che per sopravvivere alle potenze coloniali non bisognava aggrapparsi alla propria orgogliosa diversità, ma modernizzare l’esercito con armi europee e avere un ruolo nella diplomazia. Riuscì a far entrare la sua nazione nell’organizzazione mondiale della Croce Rossa, la qual cosa politicamente valeva quanto una campagna militare vinta.
Tenne rapporti diplomatici con tutte le potenze straniere europee e con l’Italia firmò il trattato di Uccialli che illuse l’Italia di una facile conquista dell’Etiopia facendone un protettorato, cosa che Menelik II non aveva nessuna intenzione di permettere.
Tra i tanti segnali che il conte Antonelli avrebbe dovuto cogliere, se fosse stato meno ingenuo, e farci riflettere sui gusti e le ambizioni del fedele alleato che ci preparavamo a adottare alla stregua di un parente povero, vi è un episodio accaduto durante la cerimonia di incoronazione a negus di Menelik II. Tra le delegazioni invitate vi era anche quella della Liberia, unico stato indipendente in Africa oltre l’Etiopia. La Liberia era stata inventata da alcune società di antischiavisti che fecero ritornare in Africa dei neri riscattati a suon di dollari dai sudisti. Era una storia molto edificante, ma che poi virò molto male, perché gli ex compagni di sventura dello zio Tom, dopo aver baciato la terra degli avi, cominciarono a trovare insopportabili e troppo primitivi i fratelli africani. Con le tasche ben imbottite di dollari e leggere di umana solidarietà, si erano messi a fare i miliardari e i padroni, rendendo schiave le sfortunate tribù locali.
La delegazione arrivata da Monrovia non stava nella pelle per la gioia di vedere un altro stato africano su cui non sventolava una bandiera europea. Il capo degli inviati incominciò con baldanza a leggere l’indirizzo di saluto al “nostro fratello negro Menelik”. Un ruggito del monarca, che pure barcollava sotto il peso di scettri e mantelli preziosissimi come se fosse un altare, lo gelò. Il neoimperatore, urlando che lui era bianchissimo e che non era certo fratello di “quelle scimmie nere”, li fece frustrare e buttare fuori dalla sala del trono.
1 Da tenere presente che i Dervisci, a parte l’impeto ed il fanatismo religioso, da un punto di vista militare non avevano alcuna possibilità di poter sconfiggere un esercito moderno, ben schierato e deciso a dare battaglia.
2 Sidney Costantino Sonnino (Pisa, 11 marzo 1847 – Roma, 24 novembre 1922) è stato un politico italiano. Ministro delle Finanze e ministro del Tesoro del Regno d’Italia dal 1893 al 1896, riportò il bilancio dello Stato al pareggio e si oppose alla dispendiosa politica aggressiva di Francesco Crispi in Etiopia. Fu Presidente del Consiglio dei ministri dall'8 febbraio al 29 maggio 1906 e dall'11 dicembre 1909 al 31 marzo 1910. Nel 1914 divenne ministro degli Esteri e con tale carica, che conservò fino al 1919, condusse le trattative che portarono alla firma del Patto di Londra con cui l'Italia si impegnava ad entrare nella Prima guerra mondiale contro l’Austria.
3 Su questo sesto senso nostrano e su questa frase ci sarebbero da scrivere enciclopedie, da Cesare a Mussolini.
 4 Taitù Batùl (1856 circa - Addis Abeba 1914). Moglie di Menelik II, imperatore d'Etiopia, da lui sposata nell'aprile 1883. Discendente di una famiglia feudale del Semien, prima dell'unione con Menelik aveva già contratto altri quattro matrimoni. Ebbe una certa influenza sulla politica di Menelik. Suo nome di battesimo era Walatta Mikā'ēl ("figlia di Michele", l'arcangelo). Menelik, che spesso tergiversava e rinviava le decisioni sgradevoli rispondendo “Sì, domani” (Ishi, nega), trovava utile avere sua moglie in una posizione abbastanza potente da dire “Assolutamente no” (Imbi) a persone e questioni che egli semplicemente non voleva offendere o rifiutare personalmente. Come risultato, l'imperatrice Taitù era sempre più impopolare, mentre Menelik rimaneva molto amato da tutti a corte.
4 Taitù Batùl (1856 circa - Addis Abeba 1914). Moglie di Menelik II, imperatore d'Etiopia, da lui sposata nell'aprile 1883. Discendente di una famiglia feudale del Semien, prima dell'unione con Menelik aveva già contratto altri quattro matrimoni. Ebbe una certa influenza sulla politica di Menelik. Suo nome di battesimo era Walatta Mikā'ēl ("figlia di Michele", l'arcangelo). Menelik, che spesso tergiversava e rinviava le decisioni sgradevoli rispondendo “Sì, domani” (Ishi, nega), trovava utile avere sua moglie in una posizione abbastanza potente da dire “Assolutamente no” (Imbi) a persone e questioni che egli semplicemente non voleva offendere o rifiutare personalmente. Come risultato, l'imperatrice Taitù era sempre più impopolare, mentre Menelik rimaneva molto amato da tutti a corte.
ADUA
Ho letto che nella storia le battaglie e le sconfitte non sono mai episodi unici, si legano sempre a qualche altra battaglia o sconfitta precedente. Così, non si capisce Adua5 se non si ripercorre quanto era successo trent’anni anni prima a Custoza (24, giugno 1866), in Lombardia, anche se in apparenza possa sembrare impossibile trovare punti di contatto tra due fatti d’arme così lontani come la terza guerra d’indipendenza e la carneficina nel Tigré.
I vertici militari di questo esordiente Regio Esercito Italiano e non più Armata Sarda, tanto per rendere le cose complicate erano ripartite in tre cariche: il re, Vittorio Emanuele II, uomo coraggiosissimo, ma non molto ferrato in tattica. Il suo potere, però, era soltanto nominale (anche questo molto italiano) perché le disposizioni ed i piani tattici toccavano a due tecnici riveriti, Alfonso La Marmora, capo di Stato maggiore, ed Enrico Cialdini, comandante del 4o corpo d’armata. I due, ovviamente, non si amavano e mai avrebbero riconosciuto la superiorità dell’altro. Così avevano pensato bene di dividere in due l’esercito, mettendo i due colleghi uno sul Mincio e l’altro sul Po. Ottima trovata psicologica, con una sola, ma gravissima pecca: vanificava la superiorità numerica, uno dei pochi, ma risolutivi vantaggi che avevamo sugli austriaci, impegnati, sul fronte tedesco, a tener testa a ben altri avversari: l’esercito prussiano di Bismarck6 e Moltke7.



Mentre noi ci impegnavamo a inventare artifizi che non offendessero la suscettibilità dei nostri generali, il comandante nemico, l’arciduca Alberto8, decideva da solo, e con assai maggiore risolutezza, dove schierare le sue truppe, salde e pronte a vendere cara la pelle.
Questa è la prima caratteristica che ritroveremo ad Adua. Dispersione del comando, beghe e gelosie tra capi, confusione su chi dovesse decidere cosa. Ancor più inquietante è il comparire di un sostantivo, “dimostrazione” unito all’inevitabile aggettivo, “energica”, che è il contributo italico alla machiavellica arte della guerra e che trent’anni dopo costituirà l’epitaffio dei nostri sforzi militari e di tanti eroismi. Questo, a riprova, che i generali non imparano mai niente e che per pigrizia preferiscono combattere sempre la guerra precedente, almeno fino a quando una dura batosta li costringe da aguzzare l’ingegno ed ad aggiornarsi. Si studiavano le campagne di Gedeone e dei Maccabei, ma non quelle italiane. E dire che La Marmora, alla richiesta dei nostri alleati prussiani di coordinare lo sforzo dei due eserciti, aveva raccomandato al suo inviato a Berlino, generale Govone9, di non “immischiarsi troppo nelle faccende di laggiù”, perché noi avevamo i nostri modi di fare la guerra.
Il generale decide di portarsi avanti per scovare il nemico, ma senza rischiare molto, poiché per la carriera una mezza sconfitta è meglio di una disfatta totale. I prussiani predicavano, già da Napoleone, da cui avevano appreso a loro spese dure lezioni su cui meditare, che lo scopo della guerra è la battaglia risolutiva su cui impegnare tutto quello che si ha per annientare il nemico, senza perdersi in tatticismi eccessivi.
La Marmora, mediocre stratega mediterraneo, va avanti a casaccio senza sapere dove stia il nemico, sparpaglia le sue forze e viene attaccato senza capire, se non dopo ore, dove vuole arrivare l’offensiva nemica. Inoltre riesce nel miracolo di combattere in una condizione di inferiorità numerica.
Il generale gira di qua e di là scambiando opinioni con i subordinati e battute con il re, il quale intuisce, a ragione, che la cosa migliore sarebbe contrattaccare risolutamente, ma nessuno gli dà retta, lui è solo il comandante nominale. A Adua, Baratieri, buon allievo di La Marmora, si troverà nella stessa antipatica condizione. I soldati al contrario si battono benissimo e sono molto motivati, vogliono contrattaccare appena si accorgono che il loro comandante è energico ed ha mantenuto il controllo.
Questo spiega perché Custoza fu una sconfitta in cui il vincitore ebbe il doppio di morti del vinto.
Il fiasco totale, invece, è nei comandi che non sanno che pesci prendere e cercano di guadagnare tempo, mentre l’arciduca imperversa tra i nostri reparti senza ordini.

Gustoso l’aneddoto del comandante in capo, il quale sul monte Croce si trova sotto l’attacco austriaco che ha preso d’infilata le sue truppe mal disposte. Il re sopraggiunge e si lamenta di avere avvertito, inascoltato, di non gettarsi in avanti, oltre il Mincio, così mal organizzati. E La Marmora risponde con filosofico fatalismo, che non si addice molto ad un comandante di eserciti: “Vostra Maestà dice bene, ma non si può saper tutto”. Più che un dialogo tra antichi strateghi di Tito Livio sembra una chiacchierata da osteria. Inoltre, impossibile dimenticare che La Marmora alla ricerca della soluzione tattica si unisce a un gruppo di sbandati in fuga, fermandosi solo a Goito, a chilometri dai combattimenti, abbandonando tutti. Eppure gli italiani resistono, anzi qualche reparto avanza contrattaccando. Quanto somiglia questa ritirata a quella penosissima di Baratieri di cui non si sa più nulla per una giornata intera, lasciando i suoi uomini senza ordini e senza guida.
Alle 13:30 la battaglia per La Marmora era già perduta. Eppure le truppe italiane erano ancora intatte e avrebbero potuto attaccare al fianco un nemico che ormai aveva dato tutto quello che poteva dare. Cialdini intanto se ne stava tranquillo ad aspettare notizie (che forse sperava cattive).
Del resto c’era l’indomani in cui ci si poteva prendere la rivincita; allora suonò la ritirata con soldati italiani in avanzata disperati per quell’ordine di retrocedere. La Marmora fu persino tentato di arretrare oltre il Po, fermato solo dalle occhiatacce degli altri generali. Perfino Cialdini ripiegò di gran carriera. Aveva di fronte solo pochi battaglioni austriaci di territoriali, che ancora anni dopo, increduli, raccontavano come avevano messo in fuga l’esercito italiano. Insomma perdemmo, ma non fu una di quelle sconfitte che ricompattano e rinforzano le coscienze dei popoli. Il fatto è che perdemmo male, non accorgendoci che potevamo vincere, anzi gettando via la vittoria. E quando finalmente avanzammo, lo facemmo in modo un po’ meschino, davanti a noi non c’era più nessuno, gli austriaci erano andati a tamponare il fronte tedesco dove Moltke, che la guerra la sapeva fare, stava puntando senza cincischiamenti verso Vienna.
Poi tanto per completare il quadro ci fu pure la sconfitta navale di Lissa, dove pur avendo una netta superiorità in navi sia corazzate che lignee, fummo sconfitti in maniera così umiliante, da far dire all’ammiraglio austriaco, schernendoci: “Navi di legno comandate da uomini con la testa di ferro hanno sconfitto navi di ferro comandate da uomini con la testa di legno”.

5 La battaglia di Adua è stata anche chiamata meno comunemente la battaglia di Abba Garima dal nome dell’altura prima della città di Adua.
6 Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen (Schönhausen, 1o aprile 1815 – Friedrichsruh, 30 luglio 1898) primo cancelliere della Germania unita di cui fu l’artefice. Determinò, attraverso un sistema di alleanze, un equilibrio in Europa isolando la Francia e contenendo le dispute tra Austria e Russia.
7 Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke (Parchim, 26 ottobre 1800 – Berlino, 24 aprile 1891) generale e feldmaresciallo prussiano, per trent’anni capo di Stato Maggiore dell’esercito prussiano. Considerato uno dei grandi geni militari paragonabili a Napoleone per la sua capacità di manovrare grandi eserciti. Grandi qualità mise in mostra anche nel campo logistico, organizzativo e, soprattutto, nella creazione del moderno lavoro di stato maggiore, creando un nuovo metodo di direzione delle forze armate sul campo, rimasto praticamente immutato, nei suoi concetti fondamentali, fino ad oggi. Diresse le guerre della Prussia contro l’Austria nel 1866 e la Francia nel 1870 sconfiggendole entrambe.
8 Alberto Federico Rodolfo d'Asburgo-Teschen (Vienna, 3 agosto 1817 – Arco, 2 febbraio 1895) è stato un generale austriaco. Noto anche come l'Arciduca Alberto, principe imperiale, arciduca D'Austria, principe reale di Ungheria e Boemia, duca di Teschen. Vincitore a Custoza contro l’esercito italiano, fu chiamato a prendere il posto del generale Benedek sconfitto a Sadowa dagli Austriaci. La sua decisione cruciale fu di richiamare a Vienna uno dei tre corpi d'armata già stanziati in Veneto, aggiungendola alle truppe ritiratesi dalla Boemia. Ciò gli consentì di costituire una nuova linea difensiva lungo il Danubio, la quale, tuttavia, non venne mai messa alla prova, dal momento che l'imperatore Francesco Giuseppe, fortemente influenzato dalla richiesta della municipalità di Vienna di dichiarare la capitale città aperta, stabilì di avviare colloqui di armistizio. Gli storici militari austriaci hanno sostenuto che tale decisione fosse quanto meno affrettata, stante il notevole apparato difensivo organizzato da Alberto. Ed è certo quest'ultimo ebbe una qualche influenza nell'indurre Bismarck ad assai ragionevoli termini di pace. Lo svantaggio principale riguardò, in effetti, il fronte italiano, ove l'esercito imperiale non seppe in alcun modo arrestare la successiva avanzata del Garibaldi e del Medici in Trentino, e quella del Cialdini attraverso il Veneto, da Ferrara sino oltre Udine. Era uno dei maggiori possidenti di terre dell’impero e ne divenne uno dei maggiori industriali. A Vienna fu colpito da una terribile, quanto incredibile, sciagura: durante un ricevimento in un castello fuori città, la sua terza figlia, Arciduchessa Matilde d'Austria, appena diciottenne, lasciò cadere la sigaretta che stava fumando sul vestito da sera, che prese fuoco e ne causò la morte di fronte all'intera famiglia.
9 Giuseppe Govone (Isola d'Asti, 19 novembre 1825 – Alba, 26 gennaio 1872) è stato un generale, politico e agente segreto italiano. Partecipò a tutte le guerre d’indipendenza, durante la guerra di Crimea caricò a Balaklava insieme alla Brigata leggera inglese. Ministro della Guerra nel 1869, ebbe nel 1870 un crollo mentale e si ritirò dalla vita pubblica. Morì suicida nella sua casa di Alba.
ADUA
La storia di Adua incomincia a Napoli nel momento in cui i fanti italiani si imbarcano per raggiungere l’Eritrea, la lontana colonia aggredita da un primitivo imperatore chiamato Menelik. Fino a quel momento Custoza è stata l’unica battaglia combattuta dall’esercito del Regno d’Italia e quella sconfitta pesava ancora enormemente sulla coscienza nazionale.
Il vizio d’origine del nuovo esercito era nel non essere sorto nuovo, giovane, fresco e già armato come Minerva dalla testa di Giove. Era il frutto compromissorio di una combinazione di tanti eserciti diversi gettati nella mischia senza curarsi se i vari elementi fossero compatibili tra di loro. Lo scheletro era formato da ufficiali del vecchio esercito sardo-piemontese. Uomini coraggiosissimi, ma anche ignorantissimi, molti anzi si facevano un vanto pubblico di questa mancanza di cultura. Eppure i tempi erano cambiati, gli eserciti si muovevano occupando decine di chilometri quadrati. Il genio di uno solo non bastava più.
Un secondo difetto, radicato anche in alcuni protagonisti della battaglia di Adua, consisteva in un’insofferenza nei confronti dei colleghi che indossavano la nuova divisa dopo aver lasciato quella dei Borboni o del Gran Duca di Toscana ed erano ormai magna pars delle nuove armate del regno. Con quelli arrivati dalle ex provincie austriache di Modena si era creata una certa solidarietà che nasceva dal reciproco rispetto, era gente che ci sapeva fare. Con gli altri, invece, i piemontesi proprio non legavano, facevano vita appartata e talvolta nei rapporti personali si sfioravano la xenofobia ed il razzismo. Gli ex ufficiali borbonici erano chiamati napulitan, i toscani etrusc e quelli che avevano servito l’ambigua moglie di Napoleone, Maria Luigia granduchessa di Parma, i “soldati del salame”, avendo la nobildonna introdotto nel rancio dei suoi soldati la specialità locale anche se poco pratica e poco marziale.
Contribuiva anche il fatto che spesso questi ufficiali non avevano mai combattuto e si erano segnalati per il rapido tradimento dei loro amatissimi sovrani o, peggio ancora, avevano conquistato le loro ultime medaglie combattendo contro garibaldini e piemontesi.
Un altro problema era che gli ufficiali della vecchia armata sarda continuavano a parlare ed impartire ordini in dialetto piemontese, nonostante le nuove severissime disposizioni che in servizio imponevano la lingua italiana. Per la maggior parte delle reclute per lo più analfabete e che parlavano solo il loro dialetto, era un problema insuperabile, ma per gli ufficiali piemontesi era un punto d’onore, e ne nascevano episodi tragicomici, che dimostravano ancora quanta strada bisognava percorrere per raggiungere l’agognata unità.
Celebre l’episodio di un capitano che riceveva le reclute per la registrazione: “Come vi chiamate?”. “Cavagna Pietro”(cavagna: cesta in dialetto piemontese). “Furé, ca lu scriva in italian: “Cesta Pietro”.
Non era solo folclore, però, le nuove disposizioni sulla lingua italiana provocarono persino richieste di congedo. Un colonnello non riusciva a spiegarsi l’improvvisa decisione di dimettersi da parte di tre abilissimi furieri; alla richiesta delle motivazioni essi risposero in coro: “Perché non si può più tenere la disciplina”. Il colonnello si mostrò alquanto stupito, immaginandosi chissà quali episodi di ammutinamento sfuggitigli. “Signùr dopo ca l’han butà l’comand “attenti!” invece del “guarda vui” ai è noun ca pia la pusisiun e ca staga cito ‘n rango” (Signore da quando hanno imposto il comando “attenti” invece del “guarda vui”, non c’è più nessuno che si metta in posizione e stia in silenzio).
Senza poi parlare delle sperequazioni che esistevano tra gli ufficiali a seconda dell’arma di provenienza, anche se i regolamenti teoricamente non lo avrebbero permesso. I genieri e gli artiglieri (l’arma di Napoleone) erano considerate le teste più fini e istruite, anche se esisteva l’altrettanta forte mentalità che tutta questa cultura poi non servisse a molto e che contava il “mordente”.
Arma a parte poi era la cavalleria, riservata a nobili teste e ricconi, anche se in evidente declino, il tempo delle cariche ormai era praticamente finito. Ma siccome nulla è più conservatore dell’esercito si continuavano a sfornare reggimenti di cavalleria che si esercitavano alla carica come ai tempi di Pastrengo10.
In più per evitare che entrassero nella nobile arma dei parvenu e la inquinassero, il regolamento imponeva un deposito di 4.000 lire per l’acquisto di due cavalli.
I fanti, invece, che formavano il gran corpo delle armate erano considerati un po’ gli iloti del nostro esercito e ci sarebbero voluti i calvari delle trincee del Carso per rivalutare l’arma. Si narrava che le signorine piemontesi di buona famiglia si facessero in quattro per impreziosire il loro salotto con un cavallerizzo od un artigliere, ma quando si presentava un ufficiale di fanteria commentavano scuotendo il capo e prevedendo una caduta di stile: “A l’è un brav fieul, ma a l’è mac ‘d’fanteria” (è un bravo ragazzo , ma è solo un fante). Comandare una brigata di fanteria era considerato un compito semplicissimo per gli ufficiali delle altre armi, in Africa metà dei comandanti provenivano dai ranghi parrucconi dell’artiglieria. Erano tempi in cui ufficiali dei bersaglieri e alpini (recenti corpi speciali di fanteria che cercavano di distinguersi per non finire travolti da così scarsa considerazione) venivano trasferiti per punizione tra i fanti di leva. Passò inosservata la gaffe di un parlamentare che, nella foga del suo intervento, in cui stava trattando di occupazioni veramente plebee usò questa infelice metafora: “Attribuzioni adatte solo a ufficiali di fanteria”.
Oggi è difficile immaginarlo, ma al tempo, l’esercito era il fulcro della nazione, lo strumento della sua sopravvivenza. I militari tutti, facevano parte di una élite, il prestigio era di diritto. Le parate militari dei giorni di festa, i cambi della guardia, in tutti i centri urbani grandi e piccoli che fossero, erano occasioni per raduni di popolo festante. E non venivano considerate cerimonie inutili, intanto rafforzavano la religione patria, era passato solo un soffio da Porta Pia, ed erano considerate un indice di buona preparazione dei soldati. Un colonnello le cui truppe sfilavano bene in parata riceveva un encomio che magari faceva dimenticare un comportamento non molto buono alle manovre militari. Insegnare a piegare a destra e sinistra era facile, bastavano quindici giorni e persino quelle mandrie di poveracci che arrivavano nei centri mobilitazione senza alcuna disciplina imparavano. Il principio ispiratore del metodo pedagogico che secondo i militari dava sempre ottimi risultati era sempre lo stesso: l’abitudine. La frase più comune che si sentiva dal tenente al generale era: “Si è sempre fatto così”. E questo principio valeva anche per la tattica e la strategia, e qui erano dolori, perché gli avversari non sempre erano abituati all’abitudine e magari a farsi sconfiggere. Ma ciò che creava più problemi agli istruttori erano le delizie del regolamento che, per un’ora al giorno, erano impartite alle reclute. Il capitano Tancredi Fogliani, riverito autore del regolamento di disciplina di quei tempi, doveva aver anima di scrittore e artista, ma non certo di psicologo. Aveva ecceduto nei ghirigori dello stile e puntato alla ben tornita prosa, forse per dimostrare che talenti letterari pulsavano anche sotto il ruvido panno delle divise, ma non si era certo preoccupato delle caratteristiche del suo pubblico, stagionati scolari, che dovevano mandare a memoria quelle massime. Per esempio la definizione del termine cardine, l’architrave su cui si regge quella cattedrale di obbedienza che era il servizio militare, la parola “ordine”. Nell’enciclopedia di concetti già dati a questa parola simbolo della disciplina militare, lui era andato a cercare il più difficile: “L’ordine è l’abito di tener ogni cosa al suo posto”. E mentre sul tener ogni cosa a posto possiamo intenderci, i guai venivano da quell’ “abito”, che era per i soldati arrivati dalla campagna del Veneto o dell’Aspromonte più complesso del concetto di ragione di Hegel. Finiva così che, interrogata, la maggioranza rispondeva per le spicce: “L’ordine è l’abito” e non c’era verso di cavargli altri sostantivi, verbi e predicati.
Le reclute mostravano un robusto senso pratico anche per le altre domande in cui riducevano la prosa del povero Fogliani all’osso: “Che cos’è lo Statuto?” Si chiedeva al poveretto, aspettandosi di veder fiorire un piccolo trattato di diritto costituzionale in cui si esaltasse la munifica bontà del re di Sardegna che aveva barattato il loro essere tali per volontà di Dio con la più mutevole volontà della nazione. E loro invece tranciavano: “É la prima domenica di giugno”, che era appunto la data in cui si festeggiava quella munifica regressione monarchica e naturalmente si veniva passati in rivista.
Queste difficoltà evidentemente non insegnavano nulla ed il principio di mandare tutto a memoria era infrangibile, peraltro anche nella scuola normale era lo stesso. Il principio veniva, però applicato, anche dove la lezione pratica sarebbe stata molto più opportuna, cioè nell’istruzione delle armi, che poi all’epoca erano quasi esclusivamente i fucili. Terminato la lunga lista dei pezzi che componevano il fucile retrocarica Wetterli, termini ripetuti all’infinito invariabilmente storpiati in un guazzabuglio di dialetti della penisola, altrimenti non se ne veniva fuori. Seguiva il corso di puntamento che consisteva principalmente, non nel prendere la mira e allenarsi ad usare il fucile, ma nel memorizzare alcuni concetti fondamentali: “Che cos’è un bersaglio o come si definisce la linea di mira? Risposta: “La visuale che dall’occhio destro del tiratore passa pel fondo della tacca di mira, sfiora la sommità del mirino e va all’oggetto che si vuole colpire”.

A Adua le truppe di Baratieri dovettero trarre gran giovamento, allorché migliaia di abissini si precipitarono a passo di corsa, davanti alla loro linea di mira e certo senza aspettare di farsi ben inquadrare. Al tempo in cui stavamo per sbarcare in Africa, 1880-85, era anche di moda una stramba teoria per cui si insegnava ai soldati di non sparare al centro del bersaglio, ma alla parte inferiore, sulla base del principio che, se non si era un tiratore provetto, si sparavano più colpi lunghi che corti e allora è meglio puntare, per esempio, sul rimbalzo, sperando che andasse bene per combinazione statistica quello che non funzionava per abilità. Ma il metodo pedagogico-militare raggiungeva l’apice nelle scuole elementari istituite nel 1873 in un momento di ispirazione nel cercare di sconfiggere l’analfabetismo che tra le reclute raggiungeva praticamente il cento per cento. Anche qui con subalpina baldanza venne stabilito che i soldati analfabeti sarebbero rimasti sotto le armi finché non avessero superato l’esame finale che dimostrava la loro capacità di saper leggere e scrivere. Legge draconiana, ferocissima, se si tiene conto che in barba al diritto romano e longobardo aveva valore retroattivo. C’erano soldati della classe 1848 con la ferma che all’epoca durava cinque anni che rischiavano di tornare a casa dopo lustri se non facevano passi da gigante a scuola. L’esame divenne così per molti un incubo e, quasi quasi, i disgraziati speravano in una pietosa pallottola che rendesse inutile quella mostruosa prova per riguadagnare la condizione di civili. Eppure c’erano ufficiali che affermavano di preferire i soldati analfabeti perché non avevano troppi grilli per la testa. Fortunatamente i governi non condivisero l’opinione e mantennero la regola, anche se poi, per le solite ragioni di bilancio nel 1886, l’esame finale fu abolito perché appesantiva troppo le classi di leva di soldati ripetenti. Un altro principio in gran voga, che sembrava potesse facilitare l’apprendimento, fu il metodo Capurro che accostava una lettera ad un oggetto, la e per esempio veniva accostata ad un orecchio, alla s un serpente , la g gli occhiali e così via. Ma il Capurro non aveva considerato che quegli irriducibili testoni finivano poi per confondere in una babele lettere e oggetti e non avanzavano di un passo. Allora gli ufficiali, imprecando contro le pensate dei comandi e il buon Capurro, tiravano fuori i soliti cartelloni e procedevano con il consueto sillabario. L’alfabetizzazione fu, però, nonostante stramberie ed aspetti grotteschi, un passo importante nella crescita del paese.
Per i giovani, quasi tutti contadini, che si ritrovavano sotto le armi, il tempo era scandito diversamente da come erano abituati, alba-tramonto-stagioni, anche la rigidità nell’abbigliamento e l’uso dello stesso non era certo abituale per loro. A marzo, per esempio, anche se avesse fatto un caldo soffocante, si doveva indossare il cappotto. I bersaglieri avevano una mantellina per la pioggia, ma da indossare solo se la pioggia fosse stata battente. Ci mancava solo che un bersagliere per una scrosciatina si riparasse come un borghese qualsiasi. Era da chiarire, però, quale fosse la soglia del maledetto aggettivo “battente”. Un maggiore interrogato a riguardo aveva risposto: “È battente quando cadendo a terra rimbalza ad altezza d’uomo”.
E proprio a novembre, quando poteva iniziare una pioggia battente, le reclute iniziavano l’addestramento che durava non meno di sei mesi, quattro ore al giorno. Si impiegavano ore sull’attenti, presentat’arm e sulla testa troppo piegata a destra o a sinistra, riposo e pied’arm. Il clou era l’allineamento in cui i prussiani erano maestri, ma che a noi sembrava ostico più dell’alfabeto turco. In genere tutto finiva sempre con una gran confusione. Questo tipo di addestramento settecentesco sollevava le proteste anche degli allievi ufficiali della recentemente istituita Accademia di Modena. Nelle piazze militari si organizzavano anche manovre a fuoco, che, cagnara a parte, non erano mai molto entusiasmanti da un punto di vista militare. Le manovre sul terreno, poi, si svolgevano sempre in direzione delle cucine da campo, perché all’ora del rancio, mezzogiorno, non c’era deroga. Con tali accorgimenti il nemico, evidentemente affamato pure lui, aveva la compiacenza di farsi annientare da una provvida Blitzkrieg e tutto finiva allegramente davanti ai pentoloni.
Le marce erano un po’ la nostra specialità, vigeva il detto napoleonico: “Volete vincere? Fate quaranta chilometri al giorno”. Non era una formalità, almeno una volta alla settimana trenta chilometri con zaini affardellati. Questo imperativo è stato così difeso dai vertici militari che ancora nel 1940, lo Stato Maggiore era convinto dell’inutilità di spendere in automezzi, tanto la fanteria sarà sempre destinata a “muoversi e a manovrare con le proprie gambe”. Parole di un maresciallo d’Italia. Peccato che gli stati maggiori nemici la pensavano diversamente.
Con tali premesse, spessissimo, le grandi manovre risultavano in un disastro. Nel 1875 per la presentazione ufficiale del nuovo esercito ai grandi d’Europa, inglesi, francesi, russi, alla presenza del Kaiser Guglielmo I, il nuovo dio della guerra e l’austriaco Francesco Giuseppe, adesso un caro nemico, l’impressione non fu buona, anche se gli ospiti furono molto diplomatici. Fecero bella figura solo i bersaglieri e gli alpini, proprio i due corpi al tempo più disprezzati dai nostri vertici militari. Per far fronte alla prospettiva di un fiasco era stata inventata la figura dell’ufficiale intrattenitore. Un simpaticone capace di divertire i colleghi con battute, barzellette, aneddoti, conversatore elegante e forbito, in grado in un batter d’occhio di distrarre la gallonata e troppo curiosa platea dei colleghi esteri nel momento in cui la manovra mostrava qualche intoppo e l’insalata dei reparti si faceva più clamorosa e umiliante. Lui parlava e quelli non si accorgevano che intanto una divisione si stava districando da un penoso ingorgo con un altro reggimento.
Cominciava in quegli anni ad emergere una nuova figura di ufficiale, l’addetto allo Stato Maggiore, visto dal resto del corpo ufficiali con un misto di invidia, avversione e sospetto, sentimenti del resto non privi di fondamento. Una battuta sosteneva che per entrare nello Stato Maggiore bisognava essere “nobili, biondi e di artiglieria”. Ma, a parziale rettifica, qualcuno aggiungeva maligno che bastavano due “b”, cioè “bel e biond”, e una “c”, cioè “ciula” ovvero “stupido” in dialetto piemontese. E pensare che secondo il parere unanime degli studiosi di strategia, la creazione dello stato maggiore aveva rappresentato un evento rivoluzionario. Napoleone era caduto anche perché continuava a pensare la guerra in solitudine, quando ormai era diventata un affare così complesso che richiedeva una sorta di trust di cervelli esperti e allenati che se ne occupasse in tempo di pace.
Il copyright spettava, manco a dirlo, ai prussiani che avevano trasferito sui campi di battaglia valori nuovi e fino ad allora giudicati con degnazione: l’organizzazione, la tenacia, la lenta accumulazione delle risorse, lo studio del terreno e dei trasporti, la psicologia del nemico e dei propri soldati e l’intendenza che nei secoli di ferro era considerata una cosa da civili o da facchini. Insomma scienza, arte e mestiere mescolati insieme secondo Moltke, fino alla prima guerra mondiale autentico Aristotele della filosofia della guerra.
Che in Italia lo Stato Maggiore non fosse molto popolare tra gli addetti ai lavori era abbastanza spiegabile.
Era infatti il contrario di tutto quanto ci entusiasmava, un metodo che stroncava pratiche che a noi piacevano moltissimo, cioè garibaldinismo e zuavismo, intesi come mitologia dell’assalto risolutore, dell’impeto e della baionetta che in guerra sono indispensabili, ma non quando vengono usati per compensare l’improvvisazione e la disorganizzazione. Questo del garibaldinismo era un’eredità pericolosa quando non collegata al buon senso di Garibaldi che l’aveva applicata con metodo e genialità, mentre gli epigoni la consideravano una specie di pietra filosofale. Insomma, imperava la teoria garibaldina che l’animo e la baionetta valgano di più del calibro dei cannoni, castroneria che ci avrebbe portato dritti a Caporetto ed El Alamein. Però almeno non eravamo in ritardo, lo Stato Maggiore era stato istituito da quel super reazionario di Vittorio Emanuele I, solo che invece di concentrare le menti militari più brillanti, divenne il rifugio di burocrati e sfaccendati amici del re o di influenti cortigiani che appesantivano i comandi di chiacchiere inutili.
Insomma il sogno era di avere uno Stato Maggiore alla prussiana, capace di vittorie come Sedan e Sadowa ed invece ci si doveva accontentare di un branco di scribacchini arroganti.
Fino a che non si capì, che il segreto era istituire un’università bellica: la Scuola di Guerra. L’accesso era estremamente selettivo, i posti per anno erano pochi e l’ammissione era legata alla benevolenza degli insegnanti. Il risultato fu che chi davvero voleva specializzarsi, doveva prima imparare l’italianissima arte di destreggiarsi tra intrighi, basse manovre e intrallazzi a cui era legato il successo.
Machiavellismi a parte la scuola era molto dura e severa. Bisognava ripetere ossessivamente, annotare, trascrivere, tanto che gli ufficiali sposati ricorrevano all’aiuto delle mogli e gli scapoli a un copista11, e queste maratone cartacee imponevano un duro lavoro serale e notturno. Gli esami erano un ripetere a memoria le lezioni dei professori stando ben attenti a non mostrare opinioni troppo personali o a non infervorarsi troppo. Era considerato un indice di indisciplina, piuttosto che di carattere, e si rischiava l’esclusione.
Chi non schiattava prima e passava l’esame finale, otteneva il brevetto con la formula magica: “Idoneo allo Stato Maggiore”. E qui cominciava il bello, perché l’ufficiale veniva assegnato in qualche ufficio dello Stato Maggiore dove passava il tempo ad addestrarsi ai wargame, copiati in genere dai prussiani, esercitazioni tattiche teoriche seguite da ricognizioni sul terreno, che poi spessissimo erano piacevoli passeggiate a cavallo nella campagna romana.
Insomma, dalla scuola uscivano, in genere, riveriti somari che andavano a rinverdire la già pessima fama di “bel, biond e ciula” con cui gli ufficiali “normali” si vendicavano di quei saccenti colleghi con il fregio dell’aquila d’oro.
Fu proprio l’Africa a chiarire quanta distanza corresse tra le ambizioni e la realtà.

La Scuola di Guerra dell’Esercito italiano fu istituita a Torino nel 1867. Da 1947 la sede è stata Civitavecchia (oggi questa storica sede ospita il Centro di Simulazione e Validazione dell'Esercito).
La Scuola di Guerra dell'Esercito di Civitavecchia è stata un istituto militare superiore per la formazione avanzata per ufficiali di carriera dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, con posti riservati per ogni corso anche a ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza e a ufficiali di forze armate straniere di paesi amici, tutti in possesso di spiccati requisiti e con diversi anni di esperienza, per la frequenza di corsi di perfezionamento propedeutici all'assunzione di responsabilità di alto livello. I corsi, originariamente strutturati su tre anni accademici, recentemente erano ridotti a due. La selezione avveniva per concorso per titoli ed esami ed era riservata normalmente a capitani anziani o a maggiori. Agli ufficiali che frequentavano con successo il corso superiore di SM per legge veniva attribuito un vantaggio di carriera consistente nella collocazione in ruolo in posizione antecedente di uno o più anni rispetto al posto occupato prima della frequenza del corso. Il conseguimento del titolo di scuola di guerra costituiva altresì un importante titolo valutabile negli avanzamenti a scelta nonché presupposto per lo svolgimento dei più delicati incarichi di SM e di comando.
La SdG ha visto più volte mutare il suo ordinamento nonché l'iter formativo dei suoi frequentatori, fino alla più recente dislocazione dei Corsi di Stato Maggiore presso la Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito a Torino e alla fusione del Corso Superiore di Stato Maggiore con l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) presso il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) in Roma.
10 Località poco a nord di Verona dove si svolse una battaglia della prima guerra d’indipendenza avvenuta il 30 aprile 1848. Il Secondo corpo d’armata dell’esercito sardo, comandato dal re Carlo Alberto, sconfisse l’esercito austriaco comandato dal maresciallo Radetzky.
11 [NdA]. Almeno da questo punto di vista fino al 1963 non era cambiato molto. Ricordo a casa mia, mio padre, allora capitano (ahimè d’artiglieria), frequentatore (si chiamavano così) della Scuola di Guerra (sita al tempo a Civitavecchia), passare nottate con i colleghi a trascrivere e copiare e le mogli effettivamente davano anche una mano.
ADUA
La dinastia imperiale etiopica, rovesciata nel 1977 dal colpo di stato militare di Hailé Menghistù12, affonda le sue radici in un passato talmente remoto da poter essere definito addirittura “biblico”. Secondo la tradizione, il suo fondatore Menelik I sarebbe nato dagli amori di re Salomone e della regina di Saba, in un periodo che gli storici collocano intorno al 1.000 - 950 a.C. La leggenda narra che Menelik si sarebbe rifugiato nella città di Axum, posta nell'Acrocoro etiopico, e vi avrebbe fondato nel 986 il cosiddetto “Regno di Axum” o axumita.
Cinque secoli più tardi Erodoto accenna alla presenza di un già solido impero africano in Etiopia, quando riporta la notizia di un'ambasceria persiana che era rimasta impressionata dalla fiera bellicosità dei popoli che lo abitavano.
La regione fu evangelizzata nel IV secolo d.C., ma in seguito la Chiesa etiopica seguì l'eresia monofisita di Eutiche, rompendo così i contatti con Roma e Costantinopoli per darsi una propria gerarchia ecclesiastica che faceva capo ad una sorta di pontefice locale detto l’abuna. L'adesione alla religione copta rimase tanto salda e connaturata tra gli etiopi che, pur essendo praticamente circondati da genti di fede musulmana, si è sempre mantenuta intatta. È interessante a questo proposito sapere che lo stesso nome di Abissinia, con il quale si usa definire il paese, è di origine araba (mentre Etiopia è di derivazione greca), e deriva dalla tribù yemenita degli Habashàt che fusero la propria stirpe semitica con le popolazioni negroidi originarie.
Il regime politico della regione si conservò stabile nei secoli assumendo un'organizzazione di tipo feudale con al vertice il negus, o imperatore, ed i suoi ras, ovvero l'aristocrazia terriera e militare che governava, godendo di molta libertà, le varie province. Come tutti i regimi feudali, quello del Leone di Giuda era perciò caratterizzato da un assai debole potere centrale e da un equilibrio alquanto precario, perché scosso da ribellioni e conflitti tra l'imperatore e la nobiltà; equilibrio capace però di rinsaldarsi istantaneamente quando una minaccia esterna faceva prevalere il fortissimo sentimento nazionale che accomunava popolo e aristocrazia.
L'immobilismo delle istituzioni etiopiche subì una notevole scossa agli inizi del XVIII secolo, quando i ras assunsero una potenza e un'indipendenza sempre più spiccate. La crisi convulsiva in cui era caduto lo Stato risultava tanto più grave in quanto, alle endemiche lotte civili interne, si aggiungevano negli anni Ottanta del secolo i pericoli esterni che insidiavano la stessa indipendenza etiopica: la calata dei dervisci musulmani dal Sudan e la penetrazione coloniale italiana dall'Eritrea.
Il 26 gennaio 1887 una colonna di 500 uomini tra nazionali, indigeni (i celebri ascari) ed irregolari, comandata dal tenente colonnello Tommaso De Cristoforis, che portava gli approvvigionamenti per la guarnigione del forte di Saati, cadde in un'imboscata presso il colle di Dogali. I guerrieri del ras Alula, circa 100.000 uomini, lasciarono in vita soltanto quei soldati che, feriti, furono creduti morti. Si trattava della prima significativa battuta d'arresto del colonialismo italiano dal 1882, allorquando era stata occupata Assab. Le perdite italiane assommarono a 423 soldati e 22 ufficiali. Gli abissini ebbero un migliaio di morti. Agli eroici caduti di Dogali, forse non tutti i romani lo sanno, fu dedicato un obelisco ed una piazza antistante la stazione Termini, che infatti si chiama Piazza dei Cinquecento.
Due anni dopo il negus Giovanni IV moriva nella battaglia di Metemma contro i dervisci, aprendo così il consueto travagliato periodo della successione al trono, che dipendeva dalla scelta dell'assemblea dei ras; un'assemblea che, di solito, fondava le proprie decisioni sul potere militare e sulla capacità di corruzione dei candidati.
12 Mènghistu Hailè Mariàm, detto il Negus Rosso (Uelaita, 21 maggio 1937), è un militare, politico, nonché primo capo di Stato etiope. Essendo stato condannato a morte per i crimini perpetrati durante il suo regime, vive in esilio in Zimbabwe.
ADUA
Chi dice che gli italiani non sanno mai quello che vogliono?
Su certi punti, anzi, siamo irremovibili.
Vogliamo la grandezza senza spese, le economie senza sacrifici e la guerra senza morti.
Il disegno è stupendo: forse difficile da effettuare.
(Ferdinando Martini, Lettere 1860-1923)
Come è stato già detto, l'interesse italiano per l'Africa, allora contesa e conquistata palmo a palmo dagli stati europei, era iniziato nel 1882. In quell'anno infatti il Ministero Depretis13 acquistò dall'armatore Rubattino di Genova la baia di Assab, che la compagnia di navigazione usava come scalo carbonifero per le sue navi. L'entusiasmo per il nuovo indirizzo della politica del Regno, che nel medesimo 1882 si collegava con Germania ed Austria nella Triplice Alleanza assurgendo a pieno titolo al rango di grande potenza, fu notevole negli ambienti della Sinistra al potere, e vi fu chi disse, come il ministro degli Affari esteri Mancini, con un'espressione indovinata, che “Le chiavi del Mediterraneo stanno nel mar Rosso”.
Contemporaneamente l'Inghilterra del premier Gladstone14, preoccupata dall'espansionismo verso meridione del movimento islamico dei dervisci, che oggi si direbbe fondamentalista, guidati da un uomo carismatico che si faceva chiamare Mahdi15, “Profeta”, il quale stava assediando a Khartoum il generale Gordon16, invitò l'Italia ad occupare Massaua, allora protetta soltanto da una piccola guarnigione egiziana, per costituire un antemurale all'avanzata incontrollabile delle bande musulmane.
Avvenne così che, il 25 febbraio 1883, il colonnello Tancredi Saletta sbarcò sulla costa prospiciente la città con un battaglione di 1.000 bersaglieri, e dette inizio alla costruzione di quella colonia che, dopo un certo tergiversare del governo sui vari nomi possibili, fu chiamata Eritrea.
Le autorità italiane si trovarono subito di fronte a due problemi militari: opporsi ai seguaci del Mahdi a nord-ovest, e penetrare in direzione dell'Abissinia ad ovest. Il primo sarebbe stato risolto brillantemente nelle quattro successive vittorie di Agordàt (27 giugno 1890), Serobèti (26 giugno 1892), della seconda Agordàt (21 dicembre 1893) e di Cassala (17 luglio 1894). L'espansione verso l'entroterra che precedette la campagna contro i dervisci portò invece allo scontro fra il più giovane regno d'Europa (35 anni) ed il più antico impero d'Africa (2700 anni). Scontro durante il quale i leoncelli italiani ebbero da imparare dal vecchio Leone di Giuda.
Un mese dopo l'episodio di Dogali, nel febbraio del 1887, il presidente del Consiglio Depretis rassegnò le dimissioni, ma Umberto I le respinse e il Gabinetto subì solo un rimpasto. Lo stanco ed ammalato statista sarebbe, però, sopravvissuto ancora solo poco tempo, poiché la morte lo colse in luglio, e l'incarico del nuovo Gabinetto fu offerto all'ex ministro degli Interni Francesco Crispi.
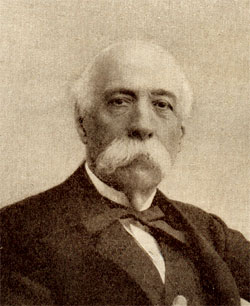
Francesco Crispi (Ribera, 4 ottobre 1818 – Napoli, 12 agosto 1901) è stato un patriota e politico italiano. Fu presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia nei periodi 29 luglio 1887 - 6 febbraio 1891 e dal 15 dicembre 1893 - 10 marzo 1896.
Avvocato e patriota, ebbe un ruolo decisivo nel convincere Garibaldi a compiere la spedizione dei Mille. Proclamata l'Unità d'Italia, abbandonò le posizioni repubblicane, aderendo alla monarchia. Divenuto presidente del Consiglio (1887-91), fu fautore di una politica “forte” all'interno e all'estero, sostenne la Triplice Alleanza (con Germania e Austria) in chiave antifrancese e promosse l'espansione coloniale. Tornò al governo nel 1893 e fronteggiò con durezza la protesta sociale (Fasci siciliani, moti in Lunigiana). Fu travolto dal naufragio delle ambizioni coloniali nella sconfitta di Adua.
La reazione dell'opinione pubblica all'eccidio di truppe italiane in Africa fu scomposta: accanto alle manifestazioni di orgoglio nazionale offeso si levarono proteste popolari contro la politica del Ministero ed anche i cinici commenti da parte di personalità politiche che tendevano a minimizzare l'entità della sconfitta. Destò ad esempio scalpore il commento del ministro degli Affari esteri Di Robilant, il cui parere era di non dare “troppa importanza ai quattro predoni che possiamo avere tra i piedi in Africa”. Ma il Governo non ebbe neppure l'appoggio degli uomini di cultura: Carducci si rifiutò di partecipare ad una commemorazione dei morti di Dogali e D'Annunzio li definì “i quattrocento bruti morti brutalmente”.
Certo è comunque che Crispi era la personalità meno adatta ad abbandonare una partita rischiosa, anche quando questa era stata cominciata da altri. Uomo tutto d'un pezzo, ex rivoluzionario mazziniano, ex garibaldino, Crispi aveva subìto nell'età matura il fascino della granitica figura di Bismarck e cercava di applicare, nel clima politico ancor immaturo dell'Italia di allora, i metodi e gli intenti del “Cancelliere di Ferro”. L'obiettivo di fondo dei suoi due ministeri, tra il 1887 e il 1896, era quello di consolidare l'Italia nel rango di grande potenza europea; e per un tale nobile scopo qualunque cosa contribuisse al prestigio della nazione, fosse una capitale profondamente trasformata da un piano regolatore, un colonialismo coronato da successi militari o una rapida espansione dell'industria e dell'economia, veniva perseguita con ostinata volontà e rigida determinazione.
Già nell'ottobre del 1887 partivano dall'Italia due grossi contingenti agli ordini del generale Di San Marzano, il Corpo Speciale d'Africa ed il Corpo di Rinforzo (13.000 uomini e 1.300 quadrupedi). Pochi mesi dopo, in aprile, il San Marzano ritornò in patria con buona parte delle truppe e venne sostituito dal generale Antonio Baldissera17 (l'unico alto ufficiale dell'Esercito che da giovane avesse militato nelle file austriache) il quale, con le pur magre forze a disposizione, ristabiliva energicamente la situazione militare e, approfittando della morte di Giovanni IV, riprendeva persino una moderata penetrazione verso il Tigré abissino (occupazione di Cheren e dell'Asmara), destinata ad essere proseguita più tardi dal generale Oreste Baratieri, un ufficiale dal passato garibaldino.
13 Agostino Depretis o De Pretis (Mezzana Corti, 31 gennaio 1813 – Stradella, 29 luglio 1887) è stato un politico italiano aderente alla sinistra storica. Fu presidente del consiglio per nove mandati.
14 William Ewart Gladstone (Liverpool, 29 dicembre 1809 – Castello di Hawarden, 19 maggio 1898) è stato un politico inglese. Ha fatto parte del Partito Liberale. È stato Primo Ministro del Regno Unito quattro volte.
15 Muhammad Ahmad ibn al-Sayyid 'Abd Allāh ibn Fahl, detto il Mahdi (Dongola, 12 agosto 1844 – Omdurman, 22 giugno 1885) è stato un capo religioso e politico sudanese.
16 Charles George Gordon (Woolwich, 28 gennaio 1833 – Khartum, 26 gennaio 1885) è stato un generale britannico, eroe nazionale sudanese. Conosciuto in Cina come il Gordon cinese, in Africa come Gordon Pascià e in Sudan come Gordon di Khartum, fu un valente ufficiale e un coordinatore dell'esercito britannico, morto durante l'assedio di Khartum da parte dei seguaci sudanesi di Muhammad Ahmad. Eroe nazionale sudanese, fu nominato cavaliere dell'ordine del Bagno e viene ricordato per le sue imprese in Cina ed in Africa del Nord.
17 Antonio Baldissera (Padova, 27 maggio 1838 – Firenze, 8 gennaio 1917) è stato un generale italiano. Nato da famiglia povera, la madre, rimasta vedova, lo porta a Udine dove è affidato alle cure del vescovo della città friulana. Il giovanissimo Antonio è accolto nella prestigiosa accademia militare di Wiener Neustadt il 29 ottobre 1849 (probabilmente grazie all'interessamento del vescovo stesso), all'età di appena 11 anni. Compiuto il regolare corso di studi e superati gli esami, inizia la sua brillante carriera militare nel Reggimento della fanteria di linea arciduca Ranieri N° 59, dove entra col grado di sottotenente di prima classe nel 1857. Promosso sottotenente di seconda classe, avanza a primo tenente il 27 maggio 1859, quando la guerra contro il Piemonte ed i suoi alleati francesi è già scoppiata. La sua esemplare condotta tenuta nel corso dei combattimenti lungo il fiume Sesia, come ufficiale di stato maggiore aggiunto al 7o Corpo d'armata, viene premiata, sebbene a posteriori, con la concessione della croce al merito militare (Ordine d'Armata N° 46 del 17 dicembre 1859). Passato effettivo nel Corpo di stato maggiore generale e promosso capitano di seconda classe il 20 luglio 1859, entra nel 7o Battaglione cacciatori da campo il 1o luglio 1860 dove avanza di prima classe nel 1864. Nel 1866, all'invito dei patrioti veneti a lasciare l'esercito austriaco, rispose che la gratitudine verso la casa imperiale per i benefici ricevuti glielo impediva. Con questo grado partecipa alla breve campagna del 1866 in Italia, aggregato allo stato maggiore del Corpo d'armata del luogotenente maresciallo di campo Maroičić. La sua buona prova nell'espletamento di questo suo incarico a Custoza, gli vale il sovrano riconoscimento di lode. Nell'ultima parte del conflitto viene trasferito al 37o Battaglione cacciatori ma poi rientra nei ranghi del 7o Battaglione. All'atto della cessione del Veneto all'Italia viene esentato dal giuramento di fedeltà all'imperatore e passa in forza al Regio Esercito dove si distingue per rigore e professionalità.



ADUA
La sorte sembrò venire in aiuto a Crispi nella partita ancora sospesa con l'Abissinia. Alla morte del negus Giovanni IV, uno dei pretendenti alla successione era il ras dello Shoa Menelik che, pur non essendo uno dei nobili più potenti, poteva tuttavia vantare una presunta discendenza diretta (il suo stesso nome ne faceva fede) dalla dinastia salomonica. Menelik d'altra parte coltivava da anni rapporti di amicizia con le autorità italiane in Eritrea e sembrava il candidato perfetto per i nostri progetti coloniali.
Artefice di un accordo diplomatico con Menelik, il quale, in cambio dell'appoggio politico contro i suoi nemici e della fornitura di armi e denaro, una volta diventato negus prometteva di accettare il protettorato italiano sull'Etiopia, fu il conte Antonelli18. Egli intendeva usare, in realtà, uno strumento vecchio quanto l'imperialismo: il sistema di assoggettare uno Stato attraverso la formale amicizia ed alleanza anziché attraverso la guerra esplicita. Lo aveva adoperato, ad esempio, Scipione quando favorì Massinissa nei confronti del suo rivale Siface in Numidia; lo avevano adottato, in moltissime occasioni, le autorità coloniali di tutto il mondo quando si trattava di inserirsi in qualche bega tribale, e per lo più aveva dato buoni frutti. Quasi sempre. Ma non in quella occasione. Menelik infatti sottoscrisse il trattato di Uccialli (località del nord dell’Etiopia) quando era ancora ras nel 1889, ma l'articolo numero 17, quello che più interessava Crispi, era differente nelle due versioni, quella italiana e quella amarica.
La versione italiana recitava infatti così:
“Sua Maestà il re d’Etiopia consente di servirsi del governo di Sua Maestà il Re d’Italia per tutte le trattazioni d’affari che avesse con altre potenze o governi”.
Mentre la versione amarica recitava:
“Sua Maestà il re d’Etiopia può trattare tutti gli affari che desidera con altre potenze o governi mediante l’aiuto di Sua Maestà il Re d’Italia”.
In poche parole il riconoscimento del protettorato italiano sull'Etiopia non c’era affatto nella versione etiopica. Quanto poi alla linea di confine tra l'Eritrea e l'Impero abissino, si rimandava ad ulteriori accordi diplomatici che non vi furono. Infine, allorché Menelik si fu impadronito del pieno potere, nel 1893 denunciò il trattato stesso.
L'Etiopia cominciò ad acquistare armi da fuoco e munizioni, sfruttando anche il prestito di 4 milioni di lire ricevuto dall'Italia dopo la firma del trattato di Uccialli. I principali fornitori di armi per l'esercito del negus furono la Russia (l'unico governo europeo a parteggiare esplicitamente per l'Etiopia) e la Francia (ancora in pessimi rapporti con l'Italia per via della questione dello “schiaffo di Tunisi19”), ma anche l'Italia stessa, che vendette al negus diverse migliaia di moderni fucili Carcano Mod. 91 e una fornitura di quattro milioni di cartucce, di vitale importanza per l'esercito etiope che non disponeva di fabbriche di polvere da sparo.
Nell'eterna favola della volpe e del corvo era stata l'Italia, che credeva di impersonare la volpe astuta, a recitare la parte del corvo sempliciotto. Se si voleva l'Etiopia, bisognava conquistarla con le armi.
La partita con il “fedifrago” Menelik non poteva certamente dirsi chiusa con l'inganno di Uccialli. Sotto il governo Crispi, poi con quello Di Rudinì20, con il primo governo Giolitti21 e infine con il secondo governo Crispi, le truppe del governatore Oreste Baratieri occuparono diverse località di confine approfittando della rivalità fra i ras ed i capi locali e nel mese d’aprile del 1895 il Tigré; vennero combattute e vinte anche modeste battaglie a Cohatit e Senafé, ed occupate le zone di Adigrat e Adua: Menelik non voleva o non poteva reagire alle provocazioni, ma le truppe che l'Italia riusciva a mandare in Africa Orientale, dopo il grande sforzo fatto con i corpi del Baldissera, erano estremamente scarse. D'altra parte l'attenzione e l'apprensione dei governi erano concentrate su ben altre questioni: la controversia doganale con la Francia, gli scandali politici, il deficit del bilancio, i fasci siciliani, i disordini in Lunigiana, i tempestosi rapporti con la Chiesa. In questo marasma di incombenze gravi e pericolose per la sicurezza del giovane Regno d'Italia, i governi metropolitani trascuravano di impartire alle autorità in Eritrea delle direttive strategiche di largo respiro; sicché esse facevano quel che potevano, approfittando degli endemici conflitti locali per erodere qualche fetta di territorio abissino e piantarvi il tricolore. Ma non è così, con l'improvvisazione e l'empirismo politico, che si conquista una colonia.
18 Antonelli Pietro, conte. Viaggiatore e diplomatico (Roma 1853 – Firenze 1901). Recatosi (1879) come privato in Etiopia, nello Shoa, soggiornò colà a lungo, adoperandosi attivamente per stabilire rapporti di amicizia fra l'allora ras dello Shoa (e poi imperatore d'Etiopia), Menelik, e l'Italia, che riuscirono a essere da lui concretati ufficialmente in un primo trattato di amicizia e commercio stipulato nel 1883. Questa politica, che mirava a legare Menelik e il suo paese permanentemente all'Italia, naufragò con il malinteso sorto circa l'articolo 17 del trattato di Uccialli, negoziato e stipulato dallo stesso Antonelli nel 1889. Deputato dal 1890, fu sotto F. Crispi sottosegretario agli Esteri (1894), poi ministro a Buenos Aires (1895) e a Rio de Janeiro (1897).
19 Lo schiaffo di Tunisi fu un'umiliazione subita dall'Italia nel 1881 ad opera dei francesi, che stabilirono il protettorato sulla Tunisia, obiettivo delle mire colonialistiche italiane. Il governo italiano, da tempo interessato al controllo coloniale della Tunisia, registra la conquista francese della regione nordafricana. L’impotenza dell’azione diplomatica del governo di fronte alle ambizioni coloniali francesi denuncia lo scarso peso internazionale del Regno d’Italia.
20 Antonio Starabba marchese di Rudinì (Palermo, 6 aprile 1839 – Roma, 6 agosto 1908) è stato un politico e prefetto italiano. Fu più volte ministro e fu presidente del Consiglio dei ministri italiano nei periodi: 6 febbraio 1891 - 15 maggio 1892 e 10 marzo 1896 - 29 giugno 1898.
21 Giovanni Giolitti (Mondovì, 27 ottobre 1842 – Cavour, 17 luglio 1928) è stato un politico italiano, più volte presidente del Consiglio dei ministri. Nella storia politica dell'Italia unita, la sua permanenza a capo del governo fu una delle più lunghe.
ADUA
Se andiamo avanti tutti sono con noi, se ci fermiamo o torniamo indietro tutti sono contro di noi. (Antico detto etiopico)
Sembra opportuno a questo punto, prima di esaminare il fatto d'arme di Adua, gettare uno sguardo al sistema organizzativo, arretrato ma sufficientemente efficace, dell'esercito etiopico con il quale ci scontrammo in quella dolorosa giornata. Innanzitutto, all'epoca di Menelik II non esisteva un unico esercito nazionale, ma tanti eserciti quante erano le regioni amministrative dello Stato governate dai singoli ras locali. Tutti gli eserciti però avevano la medesima disposizione tattica e l'identico meccanismo di leva, che erano rimasti praticamente immutati nei secoli.
Secondo una stima di origine italiana risalente al 1887, l'impero etiopico poteva mettere in campo circa 145.000 guerrieri estremamente bellicosi, la chiamata alle armi avveniva in tutto il paese. A questo punto ogni gruppo familiare era obbligato a fornire almeno uno dei propri componenti, il quale veniva retribuito durante la campagna con derrate alimentari e comunque un pasto al giorno. I più valorosi potevano poi ricevere donazioni in terre e gradi di maggiore o minore prestigio nella gerarchia militare.
Durante la marcia l'esercito nel complesso, ed ogni suo singolo reparto, anche il più piccolo, si muoveva nella medesima formazione che sarebbe stata assunta in battaglia, con il vantaggio che ogni uomo occupava negli spostamenti lo stesso posto destinato ad assumere nel combattimento, e che le truppe erano già praticamente schierate e pronte allo scontro in qualsiasi istante dell'itinerario percorso. Le tappe, dato il clima particolarmente caldo, duravano soltanto cinque ore, dalle sette del mattino a mezzogiorno; poi uomini ed animali riposavano e si rifocillavano per il resto della giornata.
L'organizzazione militare degli abissini, come abbiamo detto, era piuttosto rudimentale, in quanto non prevedeva né colonne di salmerie né una parvenza di apparato logistico, poiché i guerrieri stessi, con i loro muletti, si occupavano di trasportare tutto ciò che occorreva per sé (bagagli, viveri, armi e tende) e per la rapida costruzione dell'accampamento imperiale. A tal fine erano divisi in otto particolari categorie di portatori. Per fornire solo qualche esempio, i kodda erano adibiti al trasporto degli otri per l'acqua, i guebbar a quello dei forni da campo, delle lenticchie e della farina, i saten-ciagn portavano il pane già confezionato, mentre agli urari, che marciavano e combattevano tra le prime file, era affidata la tenda dell'imperatore (adderach) e quella dell'imperatrice (elfign).
Lo schieramento tipico degli etiopici in battaglia era a croce greca, cioè con i quattro bracci uguali. Il braccio che procedeva in testa, o avanguardia, era guidato da un alto ufficiale chiamato fitaurari; quello che costituiva l'ala destra era invece comandato dal cagnazmàcc (comandante dell’ala destra); quello di sinistra dal grazmàcc (comandante dell’ala sinistra), ed infine quello posteriore, la nostra retroguardia, dal mobò. Il degiàcc (comandante della porta) era un grado equivalente al nostro generale, ma in tempo di pace significava governatore di una provincia. Ufficiali di grado inferiore erano gli ieshambél, “comandanti dei mille”, i shambél, “comandanti dei duecentocinquanta” ed i balambaràs, “capi dei cavalieri armati di corazza”, talvolta un semplice titolo onorifico.
L'esercito abissino amava attaccare battaglia all'alba, giudicata l'ora più propizia, e nel giorno di martedì.
In caso di combattimento, il centro della croce e la retroguardia rimanevano a protezione dell'imperatore, dei dignitari e di quello che per noi sarebbe lo stato maggiore; l'avanguardia si precipitava istantaneamente all'attacco del nemico, e contemporaneamente le due ali si allargavano per avvolgerlo.
ADUA
La guerra sbagliata, nel momento sbagliato e contro la gente sbagliata. (Omar Bradley, Parla un soldato)
Tra gli anni 1890 e 1895 il Negus non si mosse, delegando di fatto ai suoi dignitari e nobili di periferia il compito di vedersela con gli Italiani. In verità egli non poteva rinunciare a difendere l'Impero, ma stava consolidando il proprio potere e acquistando armi moderne da compiacenti fornitori francesi e britannici, che non si lasciavano sfuggire nessuna occasione per mettere il bastone tra le ruote alla malferma “bicicletta” coloniale italiana.
Nel 1895 Menelik si sentì finalmente pronto a scendere in campo con il suo esercito imperiale e cominciò a muoversi verso la regione dello Shoa, la sua terra di origine. Ai segnali d'allarme che Baratieri lanciava a Roma, il Governo rispose con l'invio di appena tre battaglioni: tre battaglioni di rinforzo per operare contro un'armata superiore ai 100.000 uomini.
Con tali misere forze il maggiore Toselli, che si trovava nella zona di Amba Alagi, ed il tenente colonnello Galliano, che comandava il vicino forte di Macallé, non potevano ottenere nessun risultato diverso da quello che effettivamente ottennero: farsi annientare salvando almeno, con il loro epico sacrificio, l'onore militare d'Italia.
Il 7 dicembre 1895 un reparto comandato da Toselli e composto da un battaglione e da poche truppe indigene, venne attaccato ad Amba Alagi da tre colonne di guerrieri galla e tigrini. Gli etiopici prima misero in crisi l'ala sinistra italiana che dovette ricorrere alle riserve, poi investirono il centro ed a fine mattinata completarono l'accerchiamento. Costretti alla ritirata, con le alture alle spalle, Toselli ed i suoi seppero morire gloriosamente.
Contro il forte di Macallé, difeso da un pugno di valorosi, si spuntarono invece gli assalti del nemico. Galliano resistette pervicacemente e si rifiutò di cedere fino a che non gli giunse dal Comando l'ordine della resa, e dal negus in persona, ammirato da tanto coraggio, ottenne l'onore delle armi.
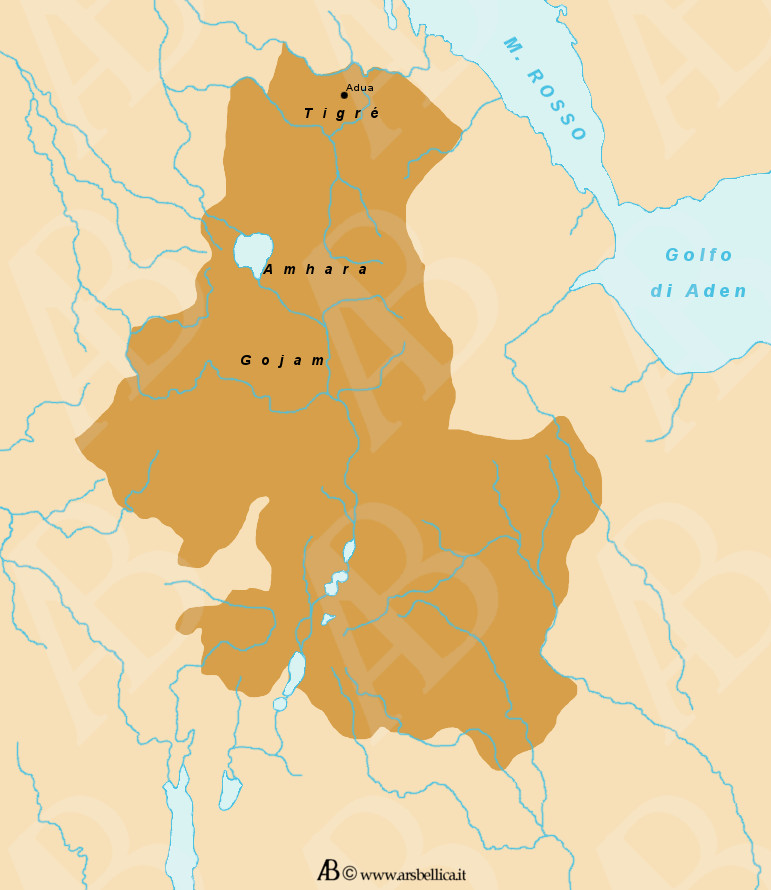
Il sacrificio di così tante vite non era stato però inutile: il generale Baratieri ebbe il tempo di organizzare apprestamenti difensivi nelle zone di confine, mentre lo stesso Menelik preferì non saggiare la capacità di resistenza italiana e scelse di marciare verso Adua. Questa manovra, erroneamente interpretata come un segno di debolezza, accompagnata dalle notizie che l'esercito imperiale era in difficoltà di approvvigionamenti e dalla considerazione che i suoi guerrieri non erano riusciti a conquistare neppure il minuscolo forte di Macallé, generò purtroppo un facile ottimismo nel Comando italiano: così, mentre gli abissini ci stimavano giustamente dei forti avversari ed applicavano la classica tattica dilazionatoria di attirarci in profondità nei loro territori per allontanarci dai rifornimenti e dalla posizioni fortificate, governo e militari pensarono invece che fosse giunto il momento di far conoscere al negus la superiorità delle armi e dei soldati italiani.
Gli europei vinsero praticamente tutti i conflitti coloniali in cui furono coinvolti anche se persero alcune battaglie. Ogni regola ha, però, delle eccezioni, e l'eccezione in questo caso è costituita dalla guerra Italo-abissina. Questa fu persa, non solo per incapacità militare, ma anche perché la nazione non aveva le necessarie risorse economiche e neppure l'orgogliosa ed ostinata fermezza di volere la rivincita dopo la prima seria sconfitta.
ADUA
Il 21 febbraio 1896 l’esercito italiano era accampato sulle alture del monte Saurià, regione dell’Entisciò. Da quel sito si potevano osservare le varie sommità che come di gradino in gradino conducevano a Adua.
L’obbiettivo italiano era frapporsi tra il nemico e le non molte strade che portavano alla colonia. Baratieri aveva con sé 16.000 soldati, Menelik II si pensava tra 80.000 e 100.000.
Le truppe italiane, quando videro che gli etiopi si erano spostati ad Adua, avevano fatto uno sforzo notevole e faticosissimo per raggiungere quella posizione strategica, 450 chilometri di marcia. Il nemico preannunciava l’intenzione di prendere la strada che da Gundapta portava alla colonia. Le marce si erano protratte anche per otto ore, superando passi e dirupi che avrebbero fatto impallidire anche un montanaro trentino.

La qualità delle truppe non era certo delle migliori, si dice che quando, in Italia, i colonnelli ricevettero l’ordine di selezionare un contingente dei loro soldati per la colonia, la scelta fosse ricaduta sui puniti, sui piantagrane e sugli indisciplinati.
Baratieri era molto preoccupato, non tanto dal negus che continuava a sfuggirgli e si rifiutava di sacrificare il suo esercito contro dei soldati europei ben trincerati, ma quanto da Crispi che lo bombardava di telegrammi. Crispi aveva un talento speciale per essere terribile e sapeva farsi ubbidire.
Il 19 dicembre lo assillarono in due, Crispi e il ministro della guerra, Stanislao Mocenni22: “A lei responsabile delle operazioni di guerra non manchi oculata prudenza e siano unica guida la opportunità militare e la necessità di non impegnarsi a fondo a rischio di un nuovo insuccesso”. Ma era la prudenza che lui aveva usato fin dal principio e che fino al giorno prima avevano definito pusillanimità! Non aveva ancora finito di leggere e di stupirsi che era arrivato un altro messaggio. Ancora lui Crispi: “Il governo non intende far politica di espansione né fare spedizioni militari all’interno dell’Abissinia. Intende chiedere al Parlamento solo i mezzi necessari per la difesa della colonia respingendo il nemico. Telegrafi se per questi obbiettivi occorrono altri rinforzi oltre i primi nove battaglioni e le tre batterie in partenza e quanti”. Un labirinto di intrighi ministeriali che in più registrava un preoccupante passaggio dal tu al voi.
Passati soli quattro giorni, gli ordini di prudenza erano già diventati isterici inviti a darsi da fare “in nome del prestigio della bandiera” e a “rioccupare la terra bagnata dal sangue italiano”.
“Dovresti conoscere la forza del nemico per poterti decidere se convenga far una campagna offensiva o mettersi sulla difensiva”, incalzava Crispi. “Nei due sistemi da seguire bisogna determinare il numero degli uomini necessari. Deciditi, non perdere tempo”. Questo era il tono con cui parlava al governatore.
Baratieri era ormai sicuro che il vecchio amico lo aveva rinnegato a scapito delle sue manovre politiche.
Anche il giorno di Natale era stato un calvario di sollecitazioni telegrafiche. Ancora il 7 gennaio: “Il governo ti ha mandato quanto hai richiesto di uomini e armi. Il paese aspetta un’altra vittoria e io l’aspetto autentica tale da definire per sempre la questione di Abissinia. Bada a quello che fai. Ci va dell’onor tuo e della dignità dell’Italia nostra. Io non ti chiedo un piano di guerra. Ti chiedo soltanto che non si ripetano le sconfitte”.
Il 23 gennaio ne giungeva un altro dello stesso tono.
Baratieri poteva solo ripetere per l’ennesima volta le sue argomentazioni di come non fosse sufficiente mandare uomini, ma occorressero reparti organici. In Italia intanto, e questo il governatore lo sapeva perché leggeva anche lui i giornali, era un susseguirsi di insulti e accuse contro di lui, il governatore impotente. Avvezzo alle sottili armi ministeriali, sapeva che si stava procedendo per distruggerlo.
I telegrammi e i commenti riservatissimi di Crispi e dei ministri cominciavano ad arrivare chissà come mai sui tavoli delle redazioni dei giornali, mentre le sue risposte rimanevano segrete e misteriose.
Poi c’erano i generali del ministero, quelli delle guerre sulla carta, che spedivano ai capi piani di come si conquista la vittoria.
Si pretendeva di comandare per telegrafo sotto la spinta dell’opinione pubblica e dell’impazienza. Dei problemi veri, come i muli, i cammelli, i trasporti non si parlava. I cammelli dai 5.000 necessari si erano ridotti a 2.300, per giunta in cattive condizioni. I cammellieri in perenne rivolta contrattuale fuggivano con i loro animali (e il carico) a decine ogni notte.
Anche Baratieri spedisce il 21 febbraio un telegramma al presidente del consiglio, il quale si sofferma su una frase: “Ventilai anche opportunità di portare corpo operazioni in posizioni più arretrate e in relazioni sicure con nostra base. Abbandonare ora attuale posizione ora ben preparata essendo in contatto con il nemico parvemi non doversi fare che in caso più grave per conseguenza morale e forse ancora materiale che poteva avere”. Crispi capì subito. Quello era lo stile di un uomo che voleva ritirarsi, che stava per trascinarlo in un'altra Macallé o peggio Amba Alagi. Le conosceva bene le arti dei generali che volevano precostituirsi una scusa. Baratieri non aveva misteri per lui. Era un uomo fragile e immodesto che aveva bisogno della vittoria e del successo, ma che di fronte alle difficoltà subiva i fatti come fossero mossi da un destino ineluttabile.
Il 21 dicembre, dopo l’Amba Alagi, il ministro della Guerra, aveva scritto di aver perso la fiducia in Baratieri e la sua impressione era che lo stesso Baratieri avesse perso la fiducia in sé stesso.
Crispi e Mocenni avevano fin d’allora scelto segretamente l’eventuale successore, il già governatore dell’Eritrea, generale Antonio Baldissera, il conquistatore dell’Asmara, strappata al ras Alula, l’inventore di quell’efficiente esercito degli ascari che costava così poco ed era così efficiente. Era chiamato dai nemici “l’austriaco” e ne aveva molti a causa dei riconoscimenti ottenuti e del carattere spigoloso. L’orfano allevato a spese dell’imperatrice Marianna d’Austria nel collegio militare imperiale, che con la divisa dei nostri ex nemici aveva raggiunto il grado di capitano. Dalla colonia se ne era andato, adducendo motivi di salute, perché in disaccordo con la politica coloniale di Roma che gli impediva di ingrandire la colonia nonostante i successi. Insomma un uomo, non proprio come quelli che amava Crispi allineati ciecamente, ma con carattere e decisionismo.
Quel telegramma di Baratieri servì a rompere gli indugi. Le esitazioni di quel generale potevano danneggiarlo e ostacolare i suoi piani di grandezza per l’Italia. Il 22 febbraio 1896 il decreto di nomina di Baldissera era già alla firma del re. La motivazione improbabile era che stava per essere, addirittura, costituito un corpo d’armata per l’Eritrea e serviva un generale con una maggiore anzianità di servizio dell’attuale comandante. La sera stessa a Brindisi in attesa di imbarcarsi per Alessandria d’Egitto, un uomo in borghese e sotto falso nome si aggirava sui moli del porto. In tasca portava la lettera di licenziamento per Baratieri, cui veniva offerto, come premio di consolazione il comando di una divisione in Eritrea. Questo suonava più che altro come un insulto.
Vennero date le disposizioni più severe per mantenere il segreto. Baratieri non doveva essere informato altrimenti sarebbe potuto venirne fuori un disastro. Al tempo, però, i giornalisti sapevano fare il loro mestiere e l’agenzia Reuter già annunciava la notizia della sostituzione, proprio mentre era imminente lo scontro con gli etiopi. Un deputato mandò addirittura un telegramma di congratulazioni al recapito di Baldissera, il quale ignaro che tutti già conoscessero la grande novità, era in viaggio nel Mediterraneo.
Baratieri anche seppe? Non ci sono prove, però uno strano telegramma, che sembrava molto un messaggio cifrato, mandato dall’Intendenza di Asmara al colonnello Eugenio Passamonti, un suo fedelissimo diceva: parte Barletta 34. La spiegazione poi data fu che si avvertiva della spedizione di 34 botti di vino di Barletta per le truppe, ma è quasi certo che la notizia del licenziamento fu inviata con queste parole. Trentaquattro erano i battaglioni che Roma aveva mandato insieme al nuovo comandante e quella B di Barletta era un riferimento al cognome Baldissera.
Il 25 febbraio poi arriva il telegramma di Crispi (cosiddetto della tisi militare) che spinge Baratieri verso decisioni fatali: “Codesta è una tisi militare, non una guerra, piccole scaramucce nelle quali ci troviamo sempre inferiori di numero al nemico; sciupio di eroismo senza successo. Non ho consigli da dare perché non mi trovo sul posto, ma constato che la campagna è condotta senza alcun piano prestabilito, e io vorrei che ce ne fosse uno. Siamo pronti a ogni sacrificio per salvare l’onore dell’esercito e il prestigio della monarchia”.

Fu proprio allora che Baratieri ebbe la certezza di essere stato licenziato, anche se non sapeva che il suo successore era già partito da tre giorni. Perché mai Crispi, che aveva imposto il più assoluto segreto sull’avvicendamento, avrebbe dovuto fare l’unica cosa che poteva mettere in allarme il governatore e spingerlo ad azioni avventate? Il presidente del Consiglio, da buon politico, aveva bisogno di una pezza giustificativa per quando la decisione sarebbe diventata pubblica: cacciare un governatore non era cosa da poco, i governanti hanno una logica diversa da quella dell’uomo comune, pensano le loro azioni in funzione della storia, degli atti parlamentari che dovranno incorniciarli e delle elezioni a venire. In quel telegramma c’era tutto quello che serviva per rispondere agli assalti dell’opposizione. Il sacrificio di cui si parlava non si riferiva a nuovi finanziamenti o a nuove truppe, ma si riferiva alla rinuncia di utilizzare lui, Baratieri. Un militare di professione probabilmente non avrebbe colto il messaggio insito in quelle parole, ma Baratieri invece, essendo un politico prestato all’esercito, sapeva che quella era la formula classica del licenziamento.
È il colpo finale alle già precarie condizioni psicofisiche del governatore. Da quel momento le sue azioni vanno lette alla luce di quel messaggio e la riprova è nelle pagine del suo libro di autodifesa, pur non accennando al telegramma. L’accusa di tisi militare per un generale non è cosa da niente.
Baratieri sicuramente con l’anima in tempesta era lacerato tra la volontà di seguire le proprie convinzioni e quello di giocarsi tutto in una battaglia, che se vittoriosa, sarebbe stata una clamorosa rivincita. Ecco il disperato disegno. Voleva far sì che i signori di Roma si trovassero nell’imbarazzo di licenziare un generale che aveva appena sconfitto il nemico. Si sarebbe ritirato, con gesto quasi napoleonico, coperto di gloria.
22 Stanislao Mocenni (Siena, 21 marzo 1837 – 1907) è stato un generale e politico italiano. Membro di una famiglia senese, giovanissimo intraprese la carriera militare e divenne ufficiale dell'esercito del Granducato di Toscana. Passato nel 1860 in quello italiano, si distinse nella repressione del brigantaggio nell'Italia meridionale. Fu nominato generale il 15 dicembre 1883. Fu deputato dal 1874 al 1900 e ministro della guerra con Francesco Crispi dal 1893 al 1896. Fu lui a proporre al consiglio dei ministri l'invio di truppe in Africa per la Battaglia di Adua e dovette dimettersi col governo Crispi a seguito proprio del tragico fallimento di tale impresa.
ADUA
Il momento di attaccare non è necessariamente quello in cui si è più pronti, ma quello in cui si è più pronti dell’avversario. (Karl Clausewitz, Della guerra)
La situazione che era venuta a crearsi era di stallo: né gli Italiani né il nemico potevano mantenersi a lungo in quelle posizioni così lontane dai rifornimenti e con la prospettiva dell'avvento della brutta stagione. Al Comando italiano si aprivano perciò tre alternative:
- rimanere nelle posizioni attuali fino a quando il Negus fosse stato costretto a sciogliere il proprio esercito perché incapace di nutrirlo. Sarebbe stata una vittoria morale;
- rientrare in Eritrea. Sarebbe stato disonorevole ed avrebbe galvanizzato gli abissini;
- tentare un'ultima avanzata, anche a rischio di provocare uno scontro con il negus, prima del ripiegamento.
Dopo l’ultimo telegramma, quest'ultima soluzione fu quella che appariva migliore a Baratieri, sia per questioni militari che per ragioni politiche. Il 28 febbraio convoca un Gran Consiglio dei suoi generali, apparentemente per prendere una decisione concordata, ma sapeva già come essi la pensavano, erano degli attaccanti ad oltranza e non aveva bisogno di consultarli. In realtà Baratieri a quel punto aveva già deciso di combattere e quella riunione gli serviva a ripararsi dietro l’ombra di una decisione condivisa all’unanimità da altri esperti uomini di guerra.
Baratieri era già stato abbastanza umiliato in quegli ultimi mesi, poiché Roma non si fidava più di lui, dal numero di generali di cui era stato circondato per un esercito così piccolo: ben cinque, incluso lui, davvero troppi.

Arimóndi Giuseppe, generale (Savigliano 1846 - monte Raio 1896). Nel dicembre 1893, ad Agordat, inflisse una sconfitta ai dervisci; si segnalò ancora ad Adi Ugri, Coatit e Senafè. In urto col generale Baratieri per questioni di politica coloniale e gelosie personali chiese, non ascoltato, di essere rimpatriato. Nella giornata di Adua, dopo aver cercato invano con la sua brigata di sottrarsi alla pressione soverchiante degli Abissini, morì in combattimento. Medaglia d'oro al valor militare alla memoria.
Il generale Giuseppe Edoardo Arimondi, sempre in contrasto con Baratieri, sapeva solo dire di attaccare. In qualsiasi altro esercito sarebbe finito sotto corte marziale per le lettere ai giornali in cui accusava il suo superiore di codardia. Il suo odio e rivalità con Baratieri duravano da anni ed erano lo spasso di tutto l’esercito. Già aveva avuto gravi responsabilità nel disastro dell’Amba Alagi23 pur di non ubbidire a Baratieri.
La sua opinione era nota: “Era tempo di aggredire il nemico, di farla finita, di cacciarlo a pedate”. Alla riunione, in piemontese disse: “Ai butôma quatr' granate e l'è faita (lanciamo quattro granate ed è fatta)”.



Albertone Matteo Francesco, generale italiano, nato ad Alessandria nel 1840. Ufficiale dei bersaglieri, poi di stato maggiore, fu insegnante alla scuola di guerra, e particolarmente noto come ufficiale coloniale. Da tenente colonnello ebbe il comando del 10o reggimento cacciatori del corpo speciale d'Africa (1888); poi il comando della piazza di Massaua, che tenne fino al 1890. Rimpatriato, fu di nuovo inviato in colonia nel 1895, e assunse il comando di una brigata di ascari eritrei, con la quale partecipò alla battaglia di Adua. Fatto prigioniero ad Adua, fu liberato 14 mesi dopo, quando fu firmata la pace italo-abissina. Per la sua condotta nella battaglia fu insignito della medaglia d'argento al valor militare. Ritiratosi volontariamente dal servizio attivo nel 1897, visse lungamente appartato e morì a Roma nel 1919.
Dabormida Vittorio, generale, nato il 22 novembre 1842 a Torino, morto ad Adua il 1o marzo 1896. Avviato come il padre, Giuseppe alla vita militare, uscì sottotenente d'artiglieria sul finire del 1861 e percorse tutta la carriera fino al grado di generale (1895), dopo aver alternato il servizio fra le truppe con delicati uffici presso il corpo di stato maggiore e l'insegnamento della storia militare nella Scuola di Guerra, rivelandosi sempre uomo di vasta e soda dottrina e caldo fautore d'una difesa del paese portata sulle Alpi. Caduto ad Adua, gli fu decretata la medaglia d'oro al valor militare.
Ellena Giuseppe, generale di cui non si hanno notizie se non che era artigliere, capitano nel 1874, probabilmente alla scuola d’artiglieria e genio di Torino, avendo lasciato scritti adottati ai corsi. Ferito, ma sopravvissuto ad Adua.
Anche i generali Albertone e Dabormida insistevano per non ritirarsi, adducendo, tra gli altri motivi l'eccellente morale delle truppe; il maggior generale Ellena, giunto da soli 12 giorni, e non essendosi fatto un quadro completo della situazione, decise di uniformarsi al parere dei colleghi più esperti.
Oltre al capo di Stato maggiore Gioacchino Valenzano nessun altro partecipava alla riunione. Escluso il maggiore Tommaso Salsa, ufficiale di stato maggiore, ascoltato consigliere di Baratieri, ma adesso in disgrazia, poiché i generali, aizzati da Arimondi che non lo poteva vedere, lo consideravano per via dei suoi gradi modesti un intruso. Inoltre non si volevano voci dissonanti. Si sapeva che certamente Salsa avrebbe ribadito, saggiamente, che non eravamo assolutamente in grado di andare ad attaccare il negus nelle sue posizioni in mezzo a montagne così scoscese e su un terreno così aspro, percorribile solo da bestie da soma e uomini scalzi; che eravamo troppo pochi e ci mancavano i mezzi di trasporto. Quindi, la soluzione migliore era rimanere attestati a sostenere l’urto del nemico da solide posizioni, poi se questo non fosse stato possibile ritirarci temporaneamente, rifornirci, rafforzarci e passare all’offensiva. Se da Roma avessero mugugnato, pazienza. Il governo doveva capire che la guerra non era una questione di pochi giorni. Salsa parlava con cognizione di causa, aveva osservato il campo del negus, avendo contato, pur empiricamente, i guerrieri armati di buoni fucili e riferito di almeno 80.000 fucilieri. Davanti a tali cifre non si poteva non essere prudenti.
Non esiste verbale della riunione per la buona ragione che una riunione tanto “democratica” era vietata dai regolamenti militari. Così le versioni si perdono in un labirinto di contraddizioni e smentite. Coloro di quelli che ebbero un ruolo chiave nel disastro e che morirono, non poterono abbandonarsi all’italica arte della smentita o della querela. Gli altri, si misero subito alla ricerca di giustificazioni che li tenesse lontani dalla corte marziale.
Baratieri trae dunque le conclusioni di quella riunione e annuncia con un piccolo colpo di scena: “Attendo ulteriori notizie di informatori che devono arrivare dal campo nemico, avutele prenderò una decisione”.
Il rinvio era tutta scena in realtà, gli ufficiali fuori dalla tenda ad attendere le decisioni, riferirono che Valenzano uscendo disse: “Siamo finalmente riusciti ad indurlo ad attaccare”.
Le sorprese, però, non erano finite, l’indomani, Baratieri, che improvvisamente fu preso da una gran fretta, decise che l’avanzata sarebbe avvenuta entro ventiquattr’ore. Una sorpresa clamorosa che ebbe, come vedremo, conseguenze nefaste sull’esito della battaglia. Nemmeno la situazione logistica giustificava quell’improvvisa ansia di mettersi in moto. Nei magazzini c’erano ancora viveri per alcuni giorni e comunque valeva la pena, prima di passare all’offensiva, di attendere la carovana in viaggio con i rifornimenti, il cui arrivo era previsto per il 2 marzo. L’unico motivo logico, inconfessabile, di quella furia era che a Baratieri era rimasto poco tempo per agire come comandante in capo. Una volta Baldissera fosse sbarcato a Massaua, avrebbe dovuto cedere il comando e prendersi tutta la vergogna di quel licenziamento.
Purtroppo i generali non avevano previsto questo rivolgimento e si erano dedicati alle loro faccende senza fretta. Il generale Albertone, per esempio, aveva spedito 1.200 dei suoi preziosissimi ascari nelle retrovie a comperare razioni di carne secca. Un battaglione intero, pattuglie varie e bande, ben 2.500 soldati, erano sparsi nella zona in un raggio di 75 chilometri, solo 700 riuscirono a partecipare alla battaglia.
Albertone certo non protestò, anche perché, informato da Baratieri e dal suo servizio di informazioni, non dovevano certo affrontare 100.000 guerrieri, ma i 20.000 della retroguardia, affamati e demoralizzati. Ma vediamo questa piccola armata a quanto ammontava con esattezza e come era disposta.
I 16.700 soldati, a parte qualche centinaio di irriducibili che marcarono visita, furono divisi in quattro brigate ognuna agli ordini di un generale.
Brigata Indigeni (gen. Albertone ): 4.076 uomini e 14 cannoni;
1a Brigata Fanteria (gen. Arimondi): 2.493 uomini e 12 cannoni (mancavano dal conto tre battaglioni spediti nelle retrovie per azioni di controguerriglia e a cui fu ordinato di rientrare in gran fretta, ma il telegramma partì con un deplorevole errore d’ortografia e finirono a rotta di collo anziché in località Jehà, nella direzione opposta Hoià);
2a Brigata Fanteria (gen. Dabormida): 3.800 uomini e 18 cannoni;
3a Brigata Fanteria (gen. Ellena): 4.150 uomini e 12 cannoni;
per un totale di 14.527 uomini e 56 cannoni.
Fu consegnato anche l’ordine di operazione, finalmente un documento scritto con timbri e firma.
Il corpo di spedizione era diviso in tre colonne: a destra gli uomini di Dabormida, al centro Arimondi, a sinistra gli ascari di Albertone. In coda sarebbe avanzata la riserva di Ellena. Partenza fissata per le 21:00, un’ora dopo per la riserva sulla scia della colonna centrale di Arimondi.
Ogni soldato aveva una dotazione di cartucce (112) e viveri per due giorni. Dovevano seguire in coda alle colonne otto muli con munizioni di scorta e medicine. Qui si dice la prima bugia perché le medicine erano finite da un pezzo ed infatti i feriti furono lasciati a se stessi.
Fu anche ordinato al responsabile del genio di stendere in gran fretta il filo telegrafico che collegava Baratieri al quartier generale a Massaua e di provvedere a piazzare i telegrafi ottici24 che consentivano di dare ordini in tempo reale alle colonne laterali. A questo punto ci fu la prima disobbedienza, quegli strumenti, che forse ci avrebbero salvato dal disastro, rimasero imballati nelle retrovie.
Le batterie furono divise tra le varie colonne, ma per scarsità di animali da soma vennero assegnati soltanto 90 colpi a pezzo in luogo dei 130 previsti. Non si poteva fare diversamente, ma così gli italiani, con una sorta di autolesionismo, limitavano l'efficienza dell'unica arma in grado di contrapporsi all'enorme superiorità numerica del nemico. Quella volontaria riduzione di granate ci faceva sparare 2.000 colpi in meno, quanto sarebbe bastato per spazzare via tutto l’esercito nemico.
Sempre nell’ordine del giorno si specificava che il primo obbiettivo era una linea formata dai colli Chidane Meret e Debbi Arienni che fugava ogni dubbio sul fatto che non si andasse a cercare lo scontro risolutivo.

Insieme all’ordine del giorno era fornito un pezzo di carta, non si può definirlo altrimenti, in cui c’era uno schizzo, tracciato con la stessa precisione con cui si sbozza una piantina per indicare sommariamente la strada ad un forestiero. Vi era disegnata, senza proporzioni e in scala sbagliata, una mappa del territorio tra Saurià e Adua. Le montagne erano disegnate alla meno peggio, le curve di livello e le strade da percorrere sembravano scarabocchi di bimbi. Chiunque avrebbe capito che con una piantina così scombinata non si andava lontano, tanto meno dare la caccia ad un nemico che conosceva a menadito i luoghi, dovendo per di più tirarsi dietro in sincronia migliaia di uomini, animali e cannoni. E di notte. Eppure una documentazione topografica accurata esisteva, bastava andare in libreria. Un geografo francese l’aveva pubblicata nel 1875 in un volume intitolato: Géodésie d’Éthiopie.
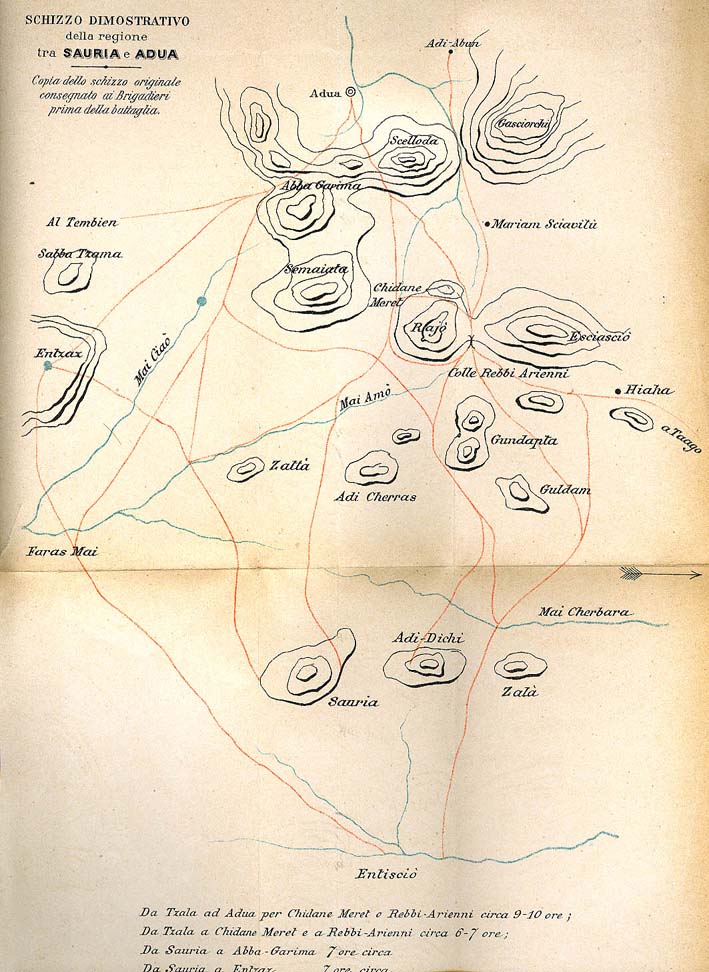
Le flebili proteste furono tacitate annunciando che ad ogni colonna erano state assegnate sei guide indigene che conoscevano quelle montagne come casa loro.
Negli anni passati eravamo stati ad Adua già tre volte, chissà perché a nessuno dello Stato maggiore non era venuto in mente di tracciare una mappa accurata per future necessità?
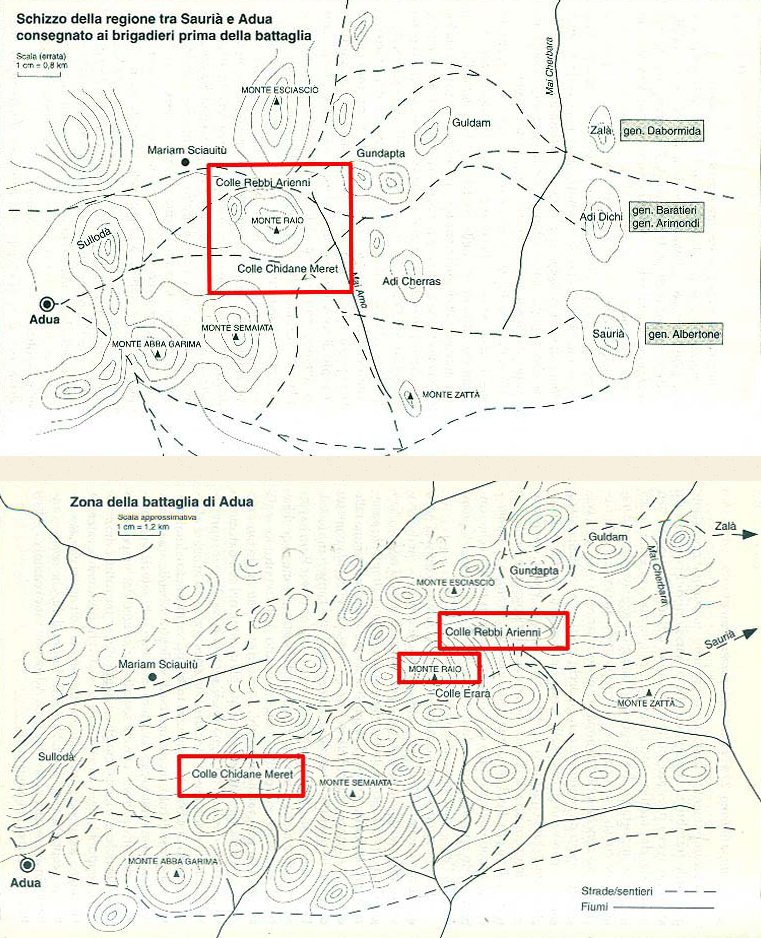
E come commentare le decisioni di Baratieri? Certamente una marcia notturna è per definizione una “marcia occulta” e suscettibile di sorprendere l'avversario, mettendolo di fronte allo sconcerto di trovare alla mattina il nemico attestato su nuove posizioni. Tuttavia uno spostamento notturno che separa le già scarse forze e procede per vie sconosciute, che non dispone di carte militari, ma soltanto di carte topografiche appena abbozzate, e si affida a delle guide locali che possono anche essere infide, espone a gravi rischi tutta l'impresa. Se poi si aggiunge che gli itinerari indicati dal Comando almeno in un'occasione risultarono sbagliati, e che la Brigata indigena della colonna di sinistra ad un certo punto si spostò (chi dice per errore, chi dice volutamente) al centro, e si trovò così alla testa della Brigata Arimondi provocandone il fatale ritardo sui tempi di marcia, bisogna concludere che gli italiani si stavano cacciando inavvertitamente in una situazione disperata.
La zona era un guazzabuglio di montagne in cui si perdeva il senso delle distanze e della profondità, i monti si susseguivano uno dopo l’altro a ritmo vertiginoso, si trattava di catene parallele divise da solchi profondi. Per avanzare si doveva scendere e risalire le cime continuamente. I valloni tra quelle montagne erano tormentati, zeppi di balzi e curve e angoli morti e le spianate si infilavano l’una nelle altre in modo così complesso che non eri mai sicuro da che parte sarebbe sbucata la prossima volta o il successivo vallone. Alle 21:00 esatte del 29 febbraio 1896 il corpo di spedizione si mise in moto.
23 Piccato per la bocciatura del suo piano che prevedeva di andare a cercare il nemico fin nel cuore dell’impero etiopico, ignorò gli ordini di ritirata impartiti da Baratieri aspettando fino all’ultimo per soccorrere la punta avanzata delle sue truppe comandate dal maggiore Toselli all’Amba Alagi.
24 Inventato dal francese Claude Chappe è un sistema telegrafico basato su una catena di segnalatori. Da una postazione successiva, distante diversi chilometri, un addetto dotato di cannocchiale riceveva il messaggio e contemporaneamente lo ripeteva in modo che lo si vedesse dalla stazione successiva.
ADUA
No poor bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making other bastards die for their country.
(Nessun povero bastardo ha mai vinto una guerra morendo per il suo paese. L’ha vinta facendo morire altri bastardi per il loro paese).
(George Smith Patton, generale statunitense)
Baratieri aveva raccomandato la compattezza e un buon collegamento tra le varie componenti di quell’esercito in modo da schierarsi prontamente in caso di necessità.
La sua preoccupazione era, come aveva più volte segnalato al ministero, che quei reparti erano raccogliticci, gli ufficiali non li conoscevano, era difficile controllare i pigri e gli insofferenti alla disciplina. Nulla da dire invece sui reparti indigeni, marciavano che era una meraviglia.
Alle 03:00 si sarebbe svolto il raduno sul colle Chidane Meret, fino a quel momento tutto filava bene.
Poi il primo intoppo, Baratieri ricevette un biglietto di Arimondi: L’avanguardia arrivando allo sbocco di Gundapta ha dovuto fermarsi per lasciar sfilare Albertone che segue la nostra medesima strada. Suppongo che la causa di questo incrocio non previsto provenga dal fatto che le due strade assegnate alle brigate hanno una parte in comune. Mi metterò in coda, assicurava il generale, ma non potrò partire dal punto in cui mi trovo prima delle quattro. Non ho ancora potuto collegarmi con la brigata Dabormida.
Le sconfitte hanno sempre un momento di inizio: quella di Adua comincia qui, dove si avvertono i primi scricchiolii della costruzione messa su in fretta da Baratieri. A non funzionare più sono i tempi, che in battaglia giocano un ruolo vitale, più del numero e del terreno.
La colonna Albertone con i suoi ascari che marciano molto rapidi ha preso un vantaggio consistente su Arimondi, che in più si è dovuto fermare. Dabormida che nessuno informa dell’impiccio, ignaro, continua ad avanzare e la distanza tra lui e le altre colonne si allarga sempre più.
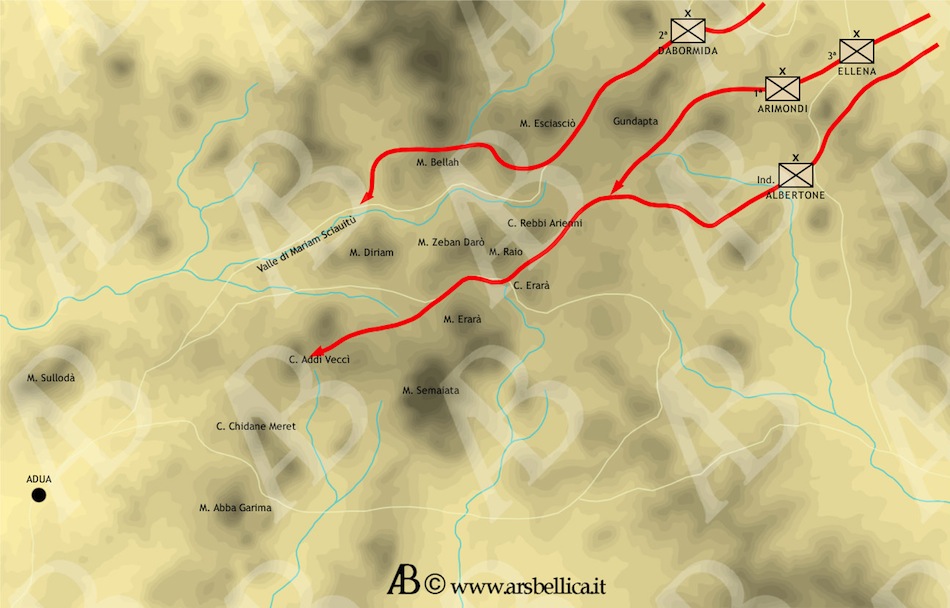
Adesso tra le due ali si è aperto un varco enorme rispetto alle colonne centrali. Perché nessuno pensa di mandare un messaggio ad Albertone con l’ordine di rallentare la marcia dei suoi ascari?
Evidentemente non viene dato molto peso alla cosa, le colonne si riuniranno più avanti, gli informatori riferiscono che davanti a loro non c’è traccia del nemico. Un comandante prudente si sarebbe fatto venire qualche dubbio. Se la prima parte del cammino, che conoscevamo bene, aveva già sfilacciato l’omogeneità dei reparti, rispettare percorsi e orari oltre il Chidane Meret, dove si entrava in una terra sconosciuta e fittamente popolata dal nemico, sarebbe stato impossibile.
Baratieri, però, commette un altro sproposito: confida che i suoi generali obbediranno agli ordini come prussiani. Albertone lo precede di un buon tratto e sarà quello, presumibilmente, che incontrerà per primo gli abissini e non ha l’appoggio al fianco dell’altra colonna. Il governatore ipotizza che Albertone si fermerà per aspettare Arimondi o Dabormida. Ma fare ipotesi è un esercizio pericoloso in quella situazione.
L’allineamento è l’ultima preoccupazione di Albertone, lui è lì per combattere e subito, prima che Baratieri si faccia prendere dai dubbi e ordini di tornare indietro. I generali se lo sono promesso l’un l’altro, quel giorno si combatterà. Inoltre ognuno di loro vuole acquisire maggior gloria possibile e Albertone è il favorito perché marcia più veloce e davanti a tutti. In più la notizia di avere davanti 20.000 demotivati guerrieri della retroguardia, lo convince che i suoi 4.000 ascari bastano ed avanzano per una grande vittoria da non condividere con nessuno e lasciare il completamento dell’annientamento finale al resto dell’esercito.
“Menelik bum bum” gridano i suoi ascari avanzando sul colle fatale.
Il generale Albertone arriva in perfetto orario su quello che secondo la sua mappa era il Chidane Meret, ma le sue guide dicono che quello è il colle Erarà, il Chidane Meret è più avanti. Il generale sa benissimo che errore della carta o no quello è il luogo dell’appuntamento, ma decide di andare ancora avanti per raggiungere il vero Chidane Meret. A seguito di questa decisione, si perse ogni probabilità, qualora ve ne fossero mai state, di vincere la battaglia.
È indiscutibile che Albertone, generale certamente competente e conoscitore della topografia, oltrepassò deliberatamente la posizione assegnatagli spinto da una volontà offensiva, sicuramente estranea al piano preparato da Baratieri.
Verosimilmente Albertone, molto favorevolmente impressionato dal fatto che nessuna traccia del nemico era stata trovata fino allora, sebbene la distanza da Adua si accorciasse rapidamente, aveva sperato di cogliere di sorpresa il campo abissino.
Il maggiore Turitto, un ufficiale con otto anni di campagne in Africa, comandante del battaglione d’avanguardia, perplesso su quella avanzata così rapida, si ferma quando un ascaro lo avvisa che si sono lasciati alle spalle da un pezzo il monte Raio, che secondo la mappa starebbe alla destra del colle Chidane Meret.
Albertone, che non vuole sentire di rallentamenti, lo investe chiedendogli ragione della sosta. E qui, come pietre cadono sulla testa del maggiore le famose parole: “Vada avanti, non voglio esitazioni. Ha forse paura?”. Turitto infuriato si lancia di corsa in avanti.
Il battaglione fu mandato in avanguardia con mezz’ora di vantaggio sul resto delle sue truppe. Un’enormità.
La circostanza, meritevole di approfondimento per gli aspetti psicologici che, pungolando nell'orgoglio un comandante possono determinare imprevedibili effetti sulla condotta delle operazioni, è senz'altro importante sul piano tattico, perché risultò una condanna per l'intero battaglione. Infatti spedito in avanti con tanto vantaggio, precedette la brigata di 3 forse 4 chilometri, prese un vantaggio che avrebbe impedito qualsiasi aiuto nel caso di impatto con il nemico. Un errore che nemmeno un sottotenente avrebbe compiuto, bastava consultare i manuali di fanteria.
In realtà tutto si chiarisce se si pensa alla “congiura”, chiamiamola così, dei quattro generali.
Bisognava, nel timore che il governatore covasse il proposito di ritirarsi dopo avere guidato una “finta” offensiva, a tutti i costi agganciare gli abissini e costringere senza possibilità di ripensamenti Baratieri a combattere. Il battaglione di Turitto serviva proprio da “esca” per cercare il contatto col nemico che si pensava in crisi logistica.
A provare che questo fosse il progetto, per lo meno di Albertone, ma probabilmente di tutti e quattro i generali, che molto avevano confabulato tra loro prima della fatale decisione di Baratieri, si aggiunge il lapsus freudiano che il comandante della brigata indigeni compie nelle sue memorie. Parla infatti di tenere i contatti alla sua destra, e cita Dabormida, mentre secondo il piano originale avrebbe dovuto esserci Arimondi. Ma l’impetuoso Arimondi stavolta ha truppe ridotte e in più è tenuto sotto controllo da Baratieri che viaggia con lui, quindi è Dabormida che dovrebbe arrivare alla sua destra e chiudere a tenaglia il nemico.
Il dolo del generale è confermato da altri indizi. E si sa che in assenza di riscontri oggettivi, più indizi tendono a formare una prova.
Un'osservazione che non può sfuggire è che se fossero state impiegate le apparecchiature per la telegrafia ottica, lasciate invece al campo di Saurià, i messaggi avrebbero potuto essere inoltrati in tempo reale, anziché impiegare più di due ore a raggiungere Baratieri. Per descrivere il comportamento doloso di tutti i comandanti di brigata, è bene evidenziare che Albertone non fu il solo ad aver dimenticato gli strumenti per telegrafare. Lo fecero tutti i brigadieri, quasi avessero temuto di dover dipendere troppo dal comando di un generale non di stato maggiore.
Ciò induce a ritenere che egli avesse la precisa volontà di allontanarsi dal resto del corpo di operazione e di poter, pertanto, agire svincolato da ogni eventuale più prudente direttiva del Baratieri. In ogni caso, pur ammettendo per un momento, solo per un momento, l'errore: anche se il generale Albertone aveva condotto la brigata indigeni parecchi chilometri oltre il punto assegnato dall'ordine di operazione, non necessariamente avrebbe dovuto impegnare battaglia.
Il generale Albertone, verso le 05:30, raggiunse il colle di Addì Veccì e da questa posizione le guide gli indicarono il vero colle Chidane Meret, a circa tre chilometri di distanza. Il generale non domanda il nome del villaggetto che presidia il colle, ma fa male perché la storia spesso nei grandi drammi si diverte a lasciare un segno beffardo e premonitore: il villaggio infatti si chiama “villaggio delle sciocchezze”.
Albertone si accorse subito che l'esercito abissino, molto più numeroso di quanto lui avesse pensato, si stava preparando all'attacco. Ma ormai il maggiore Turitto si era spinto troppo avanti. L'avanguardia si era già scagliata contro il campo shoano ed era quindi impegnata nel combattimento.
Sulla sommità del colle, sotto cui si stendeva Adua, il maggiore Turitto aveva preso una decisione incomprensibile, folle: attaccava. Forse la spiegazione di tale gesto stava nelle parole del comandante: “Ha forse paura?”.
Il generale Albertone in verità disapprovò energicamente il comportamento di Turitto che si scagliò avanti mentre aveva ordine di arrestarsi al colle di Chidame Meret. Ma si può anche credere che un attacco dell'avanguardia fosse rientrato tra le eventualità dei piani del Comandante della brigata, almeno di non voler sostenere che il maggiore Turitto, da giudicare più che un temerario, assumendosi la responsabilità di una azione tanto rischiosa, si sentisse in grado al comando di una semplice avanguardia di sconfiggere da solo buona parte dell'esercito abissino costituito da oltre 100.000 uomini.
La battaglia di Adua era cominciata.
Quello che è certo, è che Albertone ordinò al Turitto di resistere fino all'ultimo uomo, provvedendo contestualmente a mettere in posizione le sue forze costituite dai 14 pezzi di artiglieria e dal battaglione del maggiore Valle sulla sinistra, dal battaglione del maggiore Cossù sulla destra e dal battaglione del maggiore Gamerra in posizione di riserva, dietro le batterie.
Solo verso le 07:00 Albertone comunicò con il suo Comandante in capo, con l'intento di indurlo a far gravitare tutto il Corpo di operazione sulla sua posizione e di farlo in questo modo forzatamente aderire al suo piano.
Il generale Albertone finalmente decide di stabilire un contatto col suo comandante e manda un biglietto: Ore 6:50. Colle di Chidane Meret è stato occupato all’insaputa del nemico alle ore 5:00. Il nemico è tutto attorno ad Adua e dentro Marian Sciauitò. Il primo battaglione spintosi avanti al colle si è impegnato vivamente, è però sostenuto dalle bande dell’Hamasen. Il sesto battaglione occupa una forte altura di destra. Gli altri due battaglioni stanno ammassandosi con l’artiglieria. Prevedo certo un serio impegno. Avanzi la brigata Arimondi a rincalzo. Sarebbe molto opportuna avanzata brigata Dabormida che chiamerebbe a sé parte del nemico.
Quanto ai messaggi recapitati a mano, furono più quelli che andarono persi che quelli che giunsero a destinazione, il che fa di Adua, oltre tutto, un raro esempio di pessimo impiego delle comunicazioni.
Manda comunque verso destra una squadra di 100 indigeni al comando del tenente Amendolaggine per rintracciare Dabormida e sollecitarne la presenza sul campo di battaglia.
Entro due ore la brigata sarà annientata e il suo comandante non ha ancora avuto la percezione di quale disastro si sta profilando. Albertone non ha alcuna possibilità di manovrare. La ritirata è impossibile, anche se il resto dell’esercito fosse a due passi, e lui sa che non è così. Vorrebbe dire essere assaliti in marcia da un’orda inferocita, dieci volte superiore senza possibilità di difesa.
Può rimanere solo in quella posizione, meno solida di quel che appare, e resistere il più a lungo possibile.
Anziché esaminare con realismo la situazione Albertone mente. Innanzitutto non si trova sul Chidane Meret, ma sul colle che lo precede. Tace sul massacro in atto della sua avanguardia. Sostiene di aver colto il nemico di sorpresa, ma non è la verità, visto che gli stanno piombando addosso masse così numerose che nemmeno può schierare unità di retroguardia. L’avanzata di Dabormida non sarebbe affatto “opportuna” come dice lui con un lezioso aggettivo: forse non riuscirebbe neppure a cavarlo dai guai.
L’agonia del battaglione Turitto intanto si consumava sotto lo sguardo del resto della brigata, dopo un’ora di resistenza i superstiti incominciavano a retrocedere, ma non c’erano speranze.
Le nostre artiglierie cominciarono a far fuoco, intorno alle 07:15, scompaginarono le file degli abissini. Il comportamento delle batterie fu ottimo ed inizialmente molto efficace, sia da parte di quelle indigene, sia di quelle bianche, dette "siciliane" perché il personale era per lo più proveniente dalla Sicilia.
Questo fu il momento più critico per l'esercito di Menelik, che subì perdite ingenti sia tra i soldati sia tra i capi. Ad un impassibile Menelik, che osservava la battaglia, giungevano solo cattive notizie: i suoi reparti migliori venivano decimati e avevano di fronte solo un quarto delle forze italiane, se fossero giunte il resto delle truppe nemiche, cosa sarebbe stato del suo esercito?
In quei pochi momenti si giocarono le sorti della battaglia. Il seguito fu soltanto un lunghissimo scontato epilogo. Con ogni probabilità fu una donna a condannarci alla sconfitta. La regina si mise ad urlare: “Coraggio! Perché avete paura? Che ci è preso? Oggi la vittoria è nostra. Colpite senza pietà”. La regina Taitù quel giorno, fu più guerriero e ebbe più coraggio di molti ras che ormai covavano nel cuore la rassegnazione della sconfitta. L’incitamento di una donna, la necessità di non mostrarsi vili, fece sì che nessuno potesse arretrare senza perdere definitivamente la faccia, il che in Etiopia equivaleva a perdere la vita. A completare la scena giunse il Ras Mangascià del Tigré, negus mancato (era il figlio illegittimo del Negus Giovanni IV), a causa degli italiani un principe senza terra, urlante ad un tentennante Menelik di gettare nella mischia tutte le forze, inclusa la guardia imperiale. “Da otto anni faccio la guerra agli italiani e voi per un giorno non osate”.

Mangascià (amarico mangašā' "reale, regio"), ras del Tigré. Figlio adulterino del negus Giovanni IV d'Etiopia (il quale, secondo la tradizione, lo nominò suo successore in punto di morte), fu privato del trono a opera di Menelik (1889). Tentò di opporsi alla penetrazione italiana nel Tigrè ma, battuto da Baratieri a Coatif e Senafé (1895), fu costretto a riavvicinarsi al negus, insieme al quale sconfisse gli Italiani ad Adua (1896). Arrestato (1899) per essersi più volte ribellato a Menelik, morì in prigione.
Fu una frustata per l’imperatore, ordina alla sua guardia (30.000 uomini) di attaccare gli italiani frontalmente, le truppe della regina attaccheranno a destra e quelle di ras Mikael a sinistra. Per gli etiopi la vera battaglia e la vittoria cominciano proprio in quel momento.
A quel punto, il generale Albertone credette, con ogni probabilità, di aver vinto e ciò avrebbe avuto un fondamento se a sostegno fossero tempestivamente giunte le altre brigate che, con un contrattacco a massa, avrebbero potuto gettare lo scompiglio nello schieramento abissino.
Le illusioni di vittoria del generale Albertone durarono, però, poco.
La manovra shoana si rivelò molto efficace perché, mentre una grande parte dell'esercito abissino continuò il dispendioso attacco frontale, altre due colonne procedettero all'avvolgimento della brigata italiana.
La tattica era semplice, in sé, e tutti sapevano effettuarla come se l'avessero imparata a memoria. In pratica, mentre gli italiani erano sulla collina, gli abissini avanzarono attraverso le gole, lungo i greti dei torrenti fino a quando un passaggio non consentiva loro di aggirare l'avversario e di spuntargli sui fianchi o alle spalle. Va aggiunto che nel vallone ai piedi del colle vi era un “angolo morto”, come lo definiscono gli artiglieri, che permetteva di avanzare, senza essere visti, fin sotto le nostre posizioni e di balzare addosso alla brigata.
La manovra sui fianchi permise agli Shoani di capovolgere la situazione. Infatti, già alle 09:30, quasi 50.000 abissini circondarono le nostre forze cui Albertone impose di sparare fino all'ultimo colpo. Il grosso degli Shoani però continuò ad avanzare come una marea montante nera irresistibile ed i guerrieri abissini, considerati a torto imbelli e vigliacchi, dimostrarono di non temere la morte in battaglia, fornendo un esempio convincente di capacità guerriera e di attaccamento al loro sovrano.
Alle 10:30 i sentimenti di gioiosa tracotanza di Albertone si tramutarono definitivamente verso la conferma che la sua brigata stava inesorabilmente avvicinandosi alla disfatta. Le batterie sparavano, intanto, i loro ultimi colpi contro la marea shoana che, con la sua schiacciante superiorità numerica, si avvicinava sempre più pericolosamente alle postazioni italiane. Furono gli ascari per primi ad indietreggiare, incuranti degli ordini dei loro ufficiali di opporsi ulteriormente e progressivamente a difesa in quella azione che è oggi descritta come “contrasto dinamico”.
Poco prima delle 11:00, la brigata indigeni era in rotta, diretta verso il campo di Saurià, cosicché il piano di Baratieri era irrimediabilmente naufragato. Su cento ufficiali sessanta erano morti.
Il generale Albertone, cui bisogna riconoscere, mai vacillò né gli venne meno il coraggio, disse al suo aiutante: “Peccato andava così bene all’inizio. Vada. Faccia piede a terra. Non c’è nulla da fare, moriamo insieme”. Uccisa la sua cavalcatura gli furono addosso a decine, fu legato con la sua sciarpa e trascinato via.
Il generale Baratieri aveva scelto una posizione da cui poteva dominare il teatro della battaglia come un antico comandante, quando gli ordini si davano da un’altura con semplici gesti ai subordinati sottostanti. Alla sinistra il generale Arimondi stava lentamente allineando le sue truppe, alle sue spalle la brigata Ellena, ancora in marcia, si accingeva ad attestarsi sulle posizioni assegnate.
Baratieri aveva deciso di portarsi personalmente in prima linea (e secondo tutti i manuali militari era un grave errore perché così si perdeva la visione complessiva della battaglia e si rischiava di essere travolti, come avvenne, da quanto accadeva in un settore molto limitato del fronte): voleva cercare di capire cosa stesse accadendo. Nonostante i combattimenti fossero iniziati da cinque ore, e una parte del suo esercito fosse sul punto di sgretolarsi, il comandante in capo non aveva un’idea chiara di dove si trovassero intere unità della sua piccola armata. Almeno Albertone lo aveva trovato: era lì davanti a lui, a sei chilometri dalle truppe che potevano salvarlo, e stava combattendo disperatamente per sopravvivere.
Il suo subordinato, invano cercato fin dall’alba, che gli aveva inviato messaggi arroganti, privi di senso critico e di sussiegoso “gradito aiuto” adesso diventato indispensabile, ma impossibile.
Fu immediatamente scartata l’ipotesi di correre in soccorso, la brigata era troppo lontana, arrivare laggiù a ranghi compatti avrebbe richiesto non meno di due ore. E, poi, era evidente che la battaglia stava volgendo alla fine. Si incominciavano a vedere i primi segni di ritirata delle truppe indigene, non restava che schierarsi e sperare che gli ascari riuscissero a guadagnare posizioni senza subire troppi danni.
Non era l’unico guaio che affliggeva Baratieri. Adesso che aveva ritrovato Albertone era scomparso Dabormida. Lo schieramento italiano, a questo punto, prevedeva sulla sinistra ed al centro, fra il monte Rajo e lo Zeban Darò, la brigata Arimondi, verso destra; fra lo Zeban Darò e il monte Bellah, la brigata Dabormida; ancora più a destra, sul monte Erarà, il battaglione del maggiore De Amicis e la compagnia indigeni del capitano Pavesi, che aveva il compito di proteggere il fianco della brigata Dabormida; in posizione di riserva, la brigata Ellena. Secondo gli ordini Dabormida adesso avrebbe dovuto trovarsi alla sua destra sul monte Bellah, formando l’architrave di uno schieramento che poteva raccogliere la ritirata di Albertone e scongiurare il pericolo di essere scavalcati sulla destra dagli abissini. Dalla sua posizione, però, Baratieri non riusciva a scorgere niente, in mezzo c’erano le solite montagne. Un messaggio di Dabormida , portato dai primi messaggeri, annunciava di aver iniziato ad avvicinarsi al collega in difficoltà e di avere scorto la brigata indigeni. Dopodiché era calato un silenzio terribile. Di quest’azione del Dabormida che ormai doveva essere iniziata da un’ora non si vedeva traccia. Intanto il retrocedere degli ascari somigliava sempre più ad una rotta. I drappelli di sconfitti, tentavano di abbozzare una linea di difesa, ma invano ed allora la fuga riprendeva frenetica, scomparendo nei valloni da dove talvolta risaliva soltanto la massa dei vincitori.
Le distanze si dimezzavano e i cinquecento soldati del nono battaglione sembravano veramente pochi per contenere l’avanzata nemica. Perciò Baratieri ordinò al generale Ellena di spedire un reggimento di indigeni ed un paio di batterie di rinforzo. Cominciava così quello stillicidio di prelievi, una squadra là, un battaglione qua, che avrebbe esaurito la brigata di riserva, la quale sarebbe dovuta servire per piombare sul nemico nel momento decisivo dello scontro. Ma era già tardi quando il capitano Loffredo diede ordine alle sue batterie di preparasi a far fuoco: gli abissini erano a meno di duemila metri.
Quel vallone sembrava costruito apposta per una trappola. Un battaglione era stato mandato sul dorso del monte, ma la scalata era troppo ripida e si erano fermati a metà, pericolosamente isolati.
Nelle retrovie già era avvenuto il disastro, gli etiopi erano piombati sulle salmerie uccidendo i conducenti e distruggendo il materiale.
I nemici cominciavano ad apparire dalle creste e dalle valli e si vedeva che avevano una gran voglia di battersi. Il fuoco di fucileria e batteria italiano stava facendo grandi danni, ma nonostante il gran numero di caduti, il nemico continuava a farsi sotto.
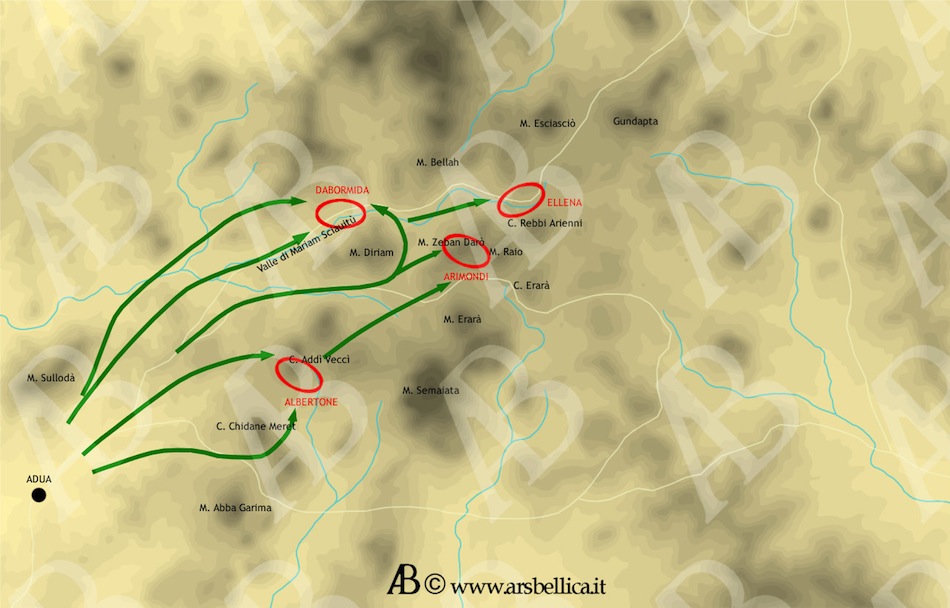
Il colonnello Stevani col suo reggimento di bersaglieri della brigata Arimondi, doveva assicurare l’ala destra, ma era preoccupato, sulle sue posizioni torreggiava il monte Zeban Darò che, nella concitazione, nessuno si era preoccupato di presidiare. Questo, anche perché, secondo i piani di Baratieri, la brigata Dabormida sistemata sul monte Belleh avrebbe dovuto coprire la posizione. Solo che della brigata Dabormida nessuno sapeva più nulla, era scomparsa. Il piano si era completamente dissolto, il piccolo esercito era spezzettato a tamponare un esercito nemico che aveva ormai l’iniziativa e decideva con oculatezza dove e da che parte attaccare.
Il colonnello mandò due compagnie sul monte a copertura del suo fianco destro e bisognava fare in fretta il nemico si avvicinava pericolosamente, oltretutto notò che tra i suoi bersaglieri, alla vista degli ascari in fuga, considerati su quel terreno invincibili, stava incominciando a insinuarsi il germe della paura.
Arrivarono in quaranta sull’altura, ma il nemico era già lì in forze, furono accolti da una fitta fucileria, non sarebbero arrivati altri bersaglieri erano già stati inchiodati in fase di arrampicamento dagli etiopi giunti alle loro spalle. Fallito il tentativo di coprirsi il fianco, Stevani sa di essere perduto. Incominciano a retrocedere, ma non per scelta tattica, solo un tentativo di sottrarsi alla pioggia di proiettili da cui sono investiti. Quindi il lato destro di Baratieri ha già ceduto.
Menelik sapeva che la vittoria non era ancora vicina, la brigata Albertone era stata annientata, ma l’esercito italiano era ancora temibile. Si portò avanti per seguire da vicino il proseguo della battaglia ponendo il suo nuovo campo nel villaggetto di Mai Agam. Fu allora che udirono una scarica di fucileria e colpi di cannone alla sua sinistra. Eppure gli avevano detto che gli italiani erano sulle pendici del monte Raio, come mai allora si sentivano rumori di battaglia nel vallone che portava ad Adua? Come mai gli italiani già pochi si erano divisi? Per un momento sospettò una trappola. Ma ormai sapeva che gli italiani non erano in numero sufficiente da potersi permettere di lanciarsi contro Adua.
Aveva due ras per risolvere quel problema, Maconnen e Alula.


Maconnèn Uoldemicaèl, meglio noto come ras Maconnèn, o con il suo nome da cavaliere Abba Qagnew (Derefo Mariam , regno dello Shoa, 9 maggio 1852 – Kulubi , regione di Harar, 21 marzo 1906), è stato un militare e politico etiope, padre di Tafarì Maconnèn, futuro imperatore d'Etiopia con il nome di Hailé Selassié I, cugino del negus Menelik con cui collaborò lealmente. Governatore della provincia di Harar ebbe una notevole parte nelle relazioni italo-etiopiche che precedettero la campagna 1895-96, nella quale egli comandava le forze che sopraffecero il maggiore Toselli ad Amba Alagi; ricevette la resa di G. Galliano a Macallè, e partecipò alla battaglia di Adua con un ruolo militare rilevante.
Alula Engid, detto anche, dal nome del suo destriero, Abba Nega (Mennawe, 1827 – Adua, 15 settembre 1897), è stato un militare e politico etiope. Ebbe il governo dello Hamasien; vincitore dei Dervisci a Kufit (1885), avversò (1887) l'espansione italiana (assalto al forte di Saati e distruzione del battaglione De Cristofori a Dogali, arresto della spedizione Salimbeni). Nel dicembre 1892 si ribellò a Mangascià e fu privato dei beni feudali; più tardi si avvicinò a Menelik col quale combatté ad Adua contro gli Italiani (1896).
La partita decisiva si giocava, però, sul monte Raio e sullo Zeban Darò. Il grosso dei nemici era attestato là e posizionati molto male, invece di essere raccolti sul punto più alto della montagna erano discesi a mezza costa. Successivamente mentre la loro artiglieria e fucileria si sarebbe accanita contro la confusione di ascari e abissini davanti a loro, i ras dovevano far andare a destra e a sinistra i loro guerrieri sui sentieri che conoscevano così bene.
Verso le 06:00, dopo una marcia notturna di quasi 10 ore, la brigata raggiunse la posizione assegnatale. Il generale Dabormida dimostrò, tra l'altro di non possedere neppure le più elementari nozioni sulla resistenza dei suoi soldati; i quali furono costretti quel giorno a passare dalla marcia al combattimento e dal combattimento alla distruzione completa, senza ristoro e senza riposo.
Tra le 06:30 e le 07:00, quando ormai si sentiva l'eco dei primi combattimenti, Dabormida, invece di attestarsi fra lo Zeban Darò ed il monte Bellàh, che rientrava nei nuovi piani di Baratieri, si incanalò verso il vallone di Mariam Shoaitù per non farne più ritorno. Il generale Baratieri, nelle sue memorie, rivelò che quanto accadde fu dovuto ad un errore, forse involontario, del Dabormida.
Rimarrà, con ogni probabilità, impossibile sapere come effettivamente si svolse la vicenda, in quanto il generale Dabormida, l'unico che avrebbe potuto fornire la testimonianza risolutiva, perse la vita sul campo di battaglia.
Dabormida, intanto, aveva commesso un altro errore, perdendo il contatto con la sua avanguardia, comandata dal maggiore De Vito.
Così, verso le 10:00, il battaglione indigeni di “milizia mobile” al comando del maggiore De Vito, investito da una violenta raffica di fuoco da parte abissina, venne rapidamente decimato.
Anche in questa occasione e per gli stessi precedenti motivi, la ritirata degli indigeni si trasformò in una rotta che contagiò anche i soldati bianchi.
Intorno alle 11:00, infatti, secondo un graduale inesorabile crescendo, la brigata Dabormida dovette sostenere l'urto della tanto celebrata cavalleria galla.
Inizialmente, il combattimento della brigata Dabormida fece segnare un momento di stasi, poiché gli abissini stavano producendo il loro massimo sforzo contro le brigate Arimondi ed Ellena.
La fase di stanca venne erroneamente valutata dagli ufficiali e dai soldati italiani che, come era già successo per la brigata Albertone, ebbero l'illusione di avere vinto. Il generale Dabormida era ferito, ma felice.
L'atmosfera ed il morale dei soldati erano, quindi, almeno in quel frangente, soddisfacenti.
Fu a questo punto, verso le 13:00, che il generale Dabormida inviò a Baratieri un messaggio per informarlo “sulla buona situazione in cui egli credeva di trovarsi”.
Fin dalle 10:30, il ripiegamento degli ascari di Albertone divenne incontrollabile ed ebbe anche un disastroso effetto sul morale delle truppe bianche, perché la ritirata degli indigeni, nella fantasia dei soldati italiani, inconsapevoli di quanto effettivamente era accaduto, assunse il significato di un “tradimento da parte dei neri”.
Inoltre, gli ascari, inseguiti da una massa imponente di abissini, giungevano nei pressi delle linee italiane frammisti ai nemici, cosicché i nostri soldati furono spesso impossibilitati a sparare per paura di colpirli.
I nostri soldati erano, ormai, senza guida in quanto, fin quasi dall'inizio della battaglia, molti reparti erano rimasti privi dei loro ufficiali anche a causa delle sciarpe azzurre e dei galloni blu e rossi che, spiccando a grandi distanze sulle tenute bianche, dettero agio ai pochi che miravano, di convergere su di essi i propri tiri.
La situazione risultò così compromessa che i soldati italiani, ai quali era stata data “la certezza della vittoria”, compresero che essa sarebbe avvenuta solo con un miracolo. Ovunque, infatti, i nostri reparti registravano gravissime difficoltà.
Insieme al terzo battaglione indigeni, comandato dal valoroso tenente colonnello Giuseppe Galliano, l'eroe di Makallè, crollava, con un'inaspettata repentina ritirata, anche la difesa di estrema sinistra. Non tutti i reparti del terzo battaglione indigeni seguirono, però, il movimento di ritirata. Alcuni, con alla testa il colonnello Galliano che cercava di arrestare la ritirata dei suoi ascari tenendoli al fuoco a colpi di staffile, tentarono inutilmente di resistere.
Caddero tutti e quattro i comandanti di compagnia: su 23 ufficiali 10 furono uccisi e sopravvissero soltanto 300 soldati.
Lo stesso colonnello Galliano, più volte ferito, si rese conto che la fine era ormai prossima, tanto che rivoltosi agli ufficiali ed agli ascari disse: “Signori, si dispongano con la loro gente e vediamo di finire bene”. Sulla fine di Galliano fiorirono leggende, ma pare la versione della sua morte, accreditata da testimonianze, sia questa.
Mentre la resistenza continuava, Galliano ferito e indebolito si era momentaneamente allontanato per cercare dell’acqua. Stava, appunto medicandosi, quando fu circondato da una banda di abissini. Alcuni lo riconobbero per averlo visto a Makallé. Lo odiavano perché ritenuto causa della morte di molti etiopi e qualcuno si ricordò anche che prima della resa aveva accettato la clausola di non combattere più contro di loro. Fu afferrato, malmenato e colpito con coltelli e scudi. Menelik informato dell’illustre cattura mandò i suoi emissari con l’ordine di portarlo al suo campo. Ma Galliano cominciò a gridare di non voler vedere “quel maiale”. Un abissino inferocito gli tagliò la testa che venne portata ai piedi del baldacchino del re. Il corpo non fu mai identificato.
Nel frattempo, Baratieri cercò di evitare il disastro ordinando l'intervento massiccio della brigata di riserva, che egli credeva ancora integra, senza sapere invece che soltanto cinque delle ventiquattro compagnie erano disponibili, in quanto da più di un'ora anche la brigata Ellena, all'insaputa di Baratieri, era impegnata nel fronteggiare gli attacchi degli abissini che, aggirato il monte Raio, si erano presentati alle spalle del contingente italiano.
I reparti del generale Ellena avevano arrancato di riserva tutta la notte accumulando un ritardo grave rispetto alla massa armata che li precedeva. Adesso che il rumore della battaglia animava tutta la zona del monte Raio riceveva richieste di spedire rinforzi dalla prima linea, evidentemente in difficoltà.
Il 3o reggimento era guidato dal tenente e principe Agostino Chigi, uno degli attendenti del governatore, che non aveva nascosto la preoccupazione quando era giunto da Ellena con la richiesta di rinforzi del suo comandante. Era partita anche tutta l’artiglieria, ma ai lati del suo schieramento cominciavano ad apparire bande di etiopi. Non sembrava una grande offensiva, finché teneva la linea del monte Raio, non c’era da preoccuparsi. Lo preoccupava di più la continua richiesta di reparti. In tal modo la sua brigata rischiava di svenarsi prima di essere impiegata per ciò a cui serviva, cioè esercitare pressione in massa dove si decideva di compiere lo scontro decisivo. La brigata che era già la più leggera tra quelle impegnate, adesso era ridotta all’osso, considerando i reparti che aveva dovuto “prestare” e quelli ritardatari. Seppe che in prima linea non stava andando molto bene e la brigata di Dabormida sembrava misteriosamente scomparsa. Ellena decise di cedere meno truppe anche perché i gruppetti di abissini erano diventati una marea e si combatteva furiosamente sui fianchi per non farsi schiacciare.
Era proprio una giornata sfortunata: a duecento metri dalla cima della vetta si videro venire addosso un tumulto di bersaglieri inseguiti da abissini sparanti e sciabolanti. Era l’ala destra del nostro schieramento, i soldati del colonnello Stevani, che, accerchiati, avevano ceduto di schianto e fuggivano verso le nostre ultime posizioni. Le truppe di Ellena tennero per non più di dieci minuti. Ellena impietrito assisteva alla distruzione dei suoi reggimenti alpini. Davanti a lui, lo spettacolo era ancora peggiore, ciò che restava dei reparti di Arimondi si sparpagliavano, si riunivano, si spostavano, fuggivano disordinatamente.
Ormai non era nemmeno più il caso di impartire ordini: adesso il combattimento era una zuffa tremenda di uomini, si lottava in una mischia confusa limitandosi a uccidere e ad essere uccisi. La ferocia, da ambo le parti, era ciò che guidava gli uomini come automi. Molti reduci anche anni dopo non riuscivano a spiegarsi quella rabbia bestiale e quell’insensatezza che non era al servizio dell’intenzione di salvare la pelle.
Era giunta anche l’ora del coraggioso, sconsiderato ed eccessivo Arimondi. Non poteva mancare in quella tragedia anche l’ultimo incontro tra i due irriducibili nemici ormai vicini alla morte. Baratieri e Arimondi si strinsero la mano senza pronunciare una parola. I due maggiori responsabili riconoscevano la disfatta e mancava loro il coraggio di interrogarsi sulle colpe reciproche. Non si dissero nulla i due. C’era grandezza in questo. Baratieri si fece dare l’elmetto piumato di generale e la spada e ordinò di suonare la fanfara reale. Poi si lanciarono nel tumulto e tentarono di fermare soldati e ufficiali in fuga. Un centinaio obbedì, fu formato un quadrato. Il governatore col principe Chigi si avviò verso il colle lentamente. Arimondi invece si sistemò presso le sue batterie e tentò di dirigere il fuoco, anche se nessuno riuscì a dargli retta. Qualche ufficiale gli gridò di fuggire, ma ottenne solo un cenno di diniego. Un suo attendente sopravvissuto dice che sia caduto mentre cercava di caricare un affusto di cannone su un mulo per sottrarlo al nemico. Altri giurarono di averlo visto con altri fuggiaschi in un villaggio mentre chiedeva da bere, ma gli abitanti saputo della sconfitta degli italiani li uccisero tutti seppellendoli poi presso la chiesa.
Dabormida aveva già avuto modo di pentirsi di quel biglietto a Baratieri in cui spiegava che stava vincendo. Non poteva sapere che non era mai giunto a destinazione, visto che il governatore stava ritirandosi in una confusione senza pari. Gli etiopi stavano aumentando sempre di più circondandoli, erano le stesse truppe che dopo aver travolto Albertone e Arimondi si erano portate nel vallone a finire il lavoro. Dabormida, quando era evidente che la strada intrapresa era sbagliata, avrebbe dovuto in gran fretta tornare indietro. I nostri generali, abituati a considerare l’offensiva una loro prerogativa, reagirono sconsideratamente ad una situazione imprevista. La brigata era allungata lungo tutto il vallone.
Dabormida comunicò al colonnello Airaghi di voler tentare un ultimo assalto, “magari si guadagna tempo e arrivano i rinforzi”, ma non doveva essere lui il rinforzo di Albertone? Il colonnello gli sorrise incredulo, il generale rispose: “Comunque ci permetterà di guadagnare spazio per ordinare la ritirata”.
Per l’ultima volta risuonò in quel vallone coperto di cadaveri il grido: “Avanti Savoia!”. Guidati da Dabormida si lanciarono in avanti, ma durò tutto una manciata di minuti, si infransero contro un muro di fucilate, gli etiopi retrocedettero di pochissimo. Fu ordinata la ritirata, raccomandando di farla lentamente e in ordine. Facile a dirsi, una volta iniziata la marcia verso l’imboccatura del vallone, l’intera pianura si riempì di nemici. Non riuscivano a muoversi, erano stati circondati. Appostato su un masso, un borghese con uno splendido fucile Winchester sparava sugli etiopi. Un tenente passando gli disse: “Bocconi25 come va?”. “Benone, tirem innans”. Parafrasando un suo concittadino il giorno che gli austriaci lo portarono al patibolo. Fu l’ultima volta che qualcuno lo vide vivo.
Il passo che permetteva di risalire sul colle Erarà, a costo di eroismi miracolosi, fu tenuto aperto dalla compagnia del tenente Rajneri, respingendo tutti gli assalti abissini. Fu l’unica nostra vittoria di quella giornata. Il sentiero era una bolgia infernale in cui l’istinto di conservazione non conobbe né pietà né riguardi.
Dabormida visto che il suo cavallo si rifiutava di andare avanti disse al suo aiutante di campo, Emilio Bellavita, di proseguire e organizzare la resistenza con Rajneri in cima al colle per consentire ai superstiti di guadagnare la vetta, lui sarebbe tornato indietro a organizzare lo sfilamento dell’artiglieria. Era una pietosa bugia, Bellavita ricordò che il generale aveva detto che da quella giornata si usciva vincitori o morti. Doveva, però, obbedire e proseguì con l’angoscia di aver abbandonato il suo comandante. Dubbio non solo suo, perché nei mesi seguenti gli toccò una dolorosa polemica con la famiglia Dabormida, che accecata dal dolore lo accusò con eccessiva severità di avere tradito la fiducia del povero generale e il giuramento di soldato. Raggiunto Rajneri e controllato che la via fosse tenuta sgombra cercò di ridiscendere alla ricerca del generale, senza successo, Dabormida nessuno l’aveva più visto.
Successivamente il fitaurari Bascià Gebrè raccontò che Dabormida l’aveva ucciso lui con un colpo di fucile mentre sparava ostinatamente rifiutandosi di arrendersi.
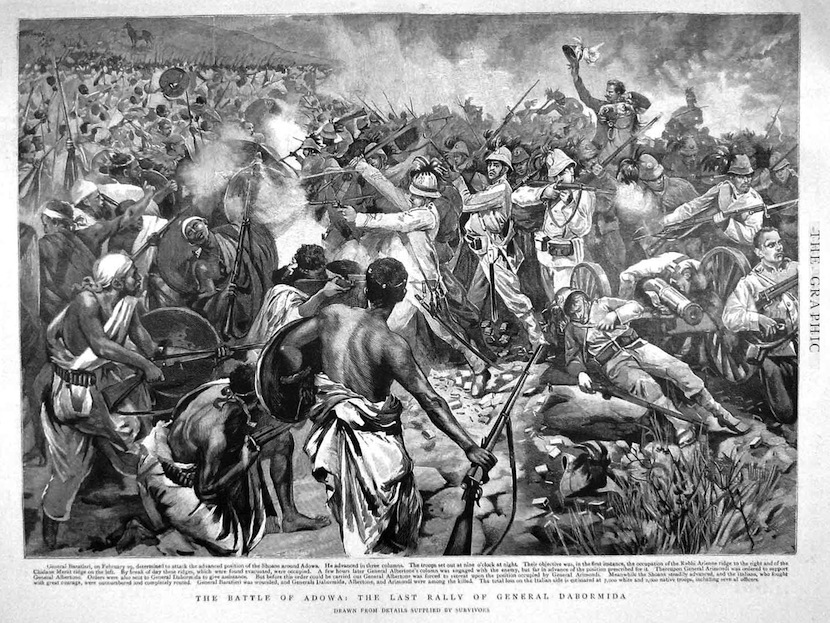
Una parte dei superstiti in fuga guidati da Valenzano aveva imboccato, dopo il Raio, una valle laterale attraverso un sentiero laterale reso invisibile da una catena di monti.
Baratieri si era posto in retroguardia e lì tentava di tenere insieme una resistenza ancora ordinata e di raccattare i resti in fuga dei vari reggimenti.
Per schivare gli abissini che occupavano il passo si erano gettati verso sinistra unendosi a quel poco che rimaneva della brigata Ellena che era ferito, sebbene non gravemente, dirigendosi verso la valle acquitrinosa di Jehà. Incredibile a dirsi, da qui speravano ancora di vedere arrivare le truppe di Dabormida. La fanteria abissina, per fortuna non li inseguiva più, la cavalleria galla sì, ma applicavano la loro tattica consueta, invece di attaccare in massa, tallonavano i fuggiaschi a gruppetti su e giù per la pianura.
I colonnelli Brusati e Stevani ormai ridotti a comandare delle compagnie guidavano la resistenza di Baratieri che sembrava avere recuperato forza e coraggio, a un certo punto piantando la bandiera su un dosso tentò di raccogliere le truppe intorno a sé, alcuni sodati si fermarono, ma la maggior parte continuò a marciare come automi. Comunque, da quel momento in poi, fino alla mattina del 3 marzo quando riapparve, di Baratieri nessuno seppe più nulla e non emanò più ordini.
Furono trovati poi nella valle, dalla delegazione che venne a seppellire le vittime, 700 cadaveri, ma molti altri sfuggirono alle ricerche. Qui la forza italiana che non era più organizzata pagò il maggior tributo, un quarto degli effettivi.
Gruppi di superstiti giunsero durante la notte all’accampamento da dove erano partiti, trovandolo distrutto e depredato, altri superstiti imboccando strade diverse giunsero in salvo fino quattro giorni dopo la battaglia. Tutto ciò sempre inseguiti e tormentati dalla cavalleria galla e dagli abitanti dei villaggi circostanti che si dedicavano al saccheggio ed alla rapina.
Un gruppo di trenta irriducibili soldati della brigata Arimondi o perché tagliati fuori o perché non volevano cedere, si erano arrampicati sul monte Raio e infilati in una profonda spaccatura, continuarono a combattere ancora per quattro giorni fino a morire tutti.
25 Bocconi Luigi, figlio dell’imprenditore milanese e senatore Ferdinando Bocconi, proprietario di grandi magazzini a Milano con diverse filiali in varie città d’Italia (alcuni anni dopo col cambio di proprietà assunsero il nome di La Rinascente). All’insaputa del padre e con un biglietto di presentazione di Crispi per Baratieri si era unito alle truppe italiane ad Adua. Il padre fondò in sua memoria l’Università Commerciale Luigi Bocconi.
ADUA
In Italia, quando giunse la notizia e, via via che passavano le ore, prendevano sempre più forma le dimensioni del disastro, le reazioni furono durissime. Le università principali si infiammarono.
A Milano, Torino, Firenze, Pavia e Napoli gli scontri con le forze dell’ordine furono violentissimi con morti e feriti. Il Ministero dell’Interno parlò chiaramente di rivolta. A Roma fu dato l’assalto alla casa di Crispi, deputati radicali arringavano e incitavano la folla. Il principe Odescalchi, in via del Tritone, riconosciuto, fu circondato e ricoperto di fango e sputi perché si rifiutava di gridare: “Viva Menelik”, ma rispose: “Sono italiano, viva l’Italia”; venne a stento salvato dai carabinieri. A Milano la stazione ferroviaria fu devastata. Risuonava sempre come refrain di quella rivoluzione il grido “viva Menelik”, mentre il paese sembrava pervaso da un furore autodistruttivo. Nei resoconti dei giornali che a loro volta alimentavano le voci, la sconfitta già pesante si ingigantiva, diventava catastrofe, quasi che le armate del negus stessero per superare il mare e comparire da un momento all’altro alle foci del Tevere. Si propagava, fu notato da molti osservatori con paura e sorpresa, una smania di auto denigrazione, di esibire la ferita anziché nasconderla; anzi di rendere quella sconfitta più terribile, irreparabile, definitiva. Quella che ora si stracciava le vesti era la stessa folla che il primo marzo, proprio mentre i nostri soldati si stavano battendo, in una serie di raduni in una trentina di città si era riunita per inneggiare alle truppe e alla scontata vittoria in Africa, riparatrice di troppi torti subiti.
Ci furono anche folli delitti legati ad Adua. In un paesino lombardo un gruppo di ragazzi che giocavano alla guerra si divisero in italiani e abissini e si batterono attorno a una cascina che era stata ribattezzata Macallé. Vinsero, naturalmente, gli italiani e, nel furore del gioco diventato improvvisamente serio, legarono a un palo il ragazzo che rappresentava Menelik, lo bastonarono e diedero fuoco alla cascina. Arrivò il proprietario che, inferocito, sfogò la sua rabbia sul povero giovane uccidendolo con una bastonata al capo. A Roma, una fanciulla di gran bellezza, ma mediocri virtù, accoltellò il suo amante, un ufficiale in partenza per l’Eritrea. Non si sa se fu vendetta per quella mancata vittoria o gelosia d’amante.
La sconfitta aveva fatto venire a galla, al di là della sua specifica importanza politica, il composto chimico di umori, rimpianti, ambizioni assai più vaste e complicate. A entusiasmarsi sulle conquiste di nuove terre erano soprattutto le regioni meridionali, dove si pensava l’avventura africana avrebbe risolto il cronico problema della povertà e dell’emigrazione, che almeno sarebbe avvenuta in una terra, lontana sì, ma battente la bandiera nazionale, senza perciò le discriminazioni e persecuzioni delle terre straniere.
Il settentrione, invece, dove le manifestazioni furono più violente e affollate, era anticrispino, ispirato, attraverso i giornali, dagli umori di una borghesia che puntava sul protezionismo e gli aiuti del governo, proprio quelli che invece vedeva sparire nelle lande africane.
A guardare bene, anche questa volta la debacle degli spiriti fu una questione di telegrammi. Uno lo aveva spedito il generale Lamberti, il vicegovernatore, da Massaua e, tutto sommato, a parte alcune inesattezze, riportava una ricostruzione della battaglia abbastanza fedele, dall’avanzamento affrettato della colonna Albertone, al numero preponderante del nemico. Nessun accenno ad atti di valore ed eroiche e titaniche resistenze con cui in genere i generali addolcivano i bocconi amari. Una sconfitta e basta, provocata da un terreno difficile, un generale imprudente e, magari, anche dal valore dell’avversario. Una lettura corretta, ma che purtroppo non passò.
Perché la versione che finì sui giornali e scatenò l’ira della gente e una mezza rivoluzione fu quella di un altro generale, Baratieri. Fino a quel momento solo un comandante sfortunato e inferiore ai suoi compiti, che aveva perso un’importante, ma non decisiva battaglia e che non aveva incontrato la fortuna di una pallottola o di un colpo di lancia che lo avesse ammazzato. In questo caso ci sarebbero oggi moltissime piazze Baratieri. Ma alla colpa di essere vivo, mentre erano morti migliaia dei suoi soldati, si aggiunse qualcosa di molto più grave. Baratieri si rivelò nella disgrazia quello che era: un uomo meschino, altamente inferiore nel morale e nel carattere alla sua spropositata fortuna.
Il governatore, lacero e depresso, ma vivo, arrivò ad Adi Caièh alle 15:00 del 2 marzo. C’erano ancora migliaia di soldati da soccorrere e salvare, bisognava organizzare la difesa della colonia e studiare le contromosse in caso di avanzata del negus. Tutte cose a cui in pochi minuti, provvide poi Baldissera, in quel momento a un giorno di navigazione da Massaua. E infatti rimise tutto a posto. Invece, per quasi dodici ore, Baratieri sparì. Nessun ordine, nessuna disposizione: il governatore e ancora comandante in capo era letteralmente scomparso e restò muto.
Si era chiuso con il fedele colonnello Valenzano per centellinare il telegramma ufficiale con la notizia della sconfitta da dettare a Roma. Baratieri sapeva che con quella prosa si giocava la carriera perché dell’entità del disastro e delle sue colpe era certamente consapevole. Come tutti i vili, aveva già cominciato a trasferire ogni responsabilità sul groppone di altri, comandanti, soldati e politici, che non avevano obbedito, appoggiato, ascoltato e rifornito. Era un lavoro non da poco e il generale non aveva molto tempo da sprecare per altre incombenze, come prendersi cura dei soldati a cui peraltro stava per tirare il colpo di grazia, tanto feroce quanto inaspettato e crudele. Agli stessi che fino a poc’anzi avevano gridato “viva Baratieri”.
Uscì da quella lunga concertazione uno dei documenti più vergognosi (ma non l’unico nel suo genere) della storia d’Italia. Era molto di più di un’informazione di sconfitta al capo del governo. Era il primo documento di autodifesa e un manuale di scaricabarile e di calunnia ai danni di chi non si poteva difendere perché morto o prigioniero o perché impossibilitato a replicare per grado e condizione. Senza dimenticare che Baratieri dal 29 febbraio, quando decise l’attacco, non aveva più dato notizie di sé né preavvisato il governo della sua decisione di attaccare risolutamente il nemico.
Telegramma inviato dal generale Oreste Baratieri al Governo, la mattina del 3 marzo 1896:
“Sabato decisi azione contro posizioni avanzate Shoani verso Adua, perciò avanzai con tre colonne comunicanti tra loro e una riserva generale.
Colonna destra: Dabormida, sei battaglioni bianchi, quattro batterie battaglione milizia.
Colonna centro: Arimondi, con cinque battaglioni bianchi, reparto indigeni, due batterie.
Colonna sinistra: Albertone, quattro battaglioni indigeni, quattro batterie.
Riserva: Ellena, sei battaglioni bianchi, uno indigeni, due batterie tiro rapido.
Le due colonne laterali dovevano percorrere le due strade che dalla posizione di Saria mettono nella conca di Adua. La centrale tenere collegamento per la strada di mezzo, sulla quale marciava pure la riserva. Partenza ore 21 profittando della luna. Obiettivo primo: occupazione a destra colle Rebbi Arieni, a sinistra colle Chidane Meret; questi colli per i quali passano le due strade parallele, sono separati da una roccia caratteristica a picco, monte Raio, ma le comunicazioni sono relativamente facili oltre essa, cioè a ovest e sono in vista tra loro.
Operazione si svolse come era prescritto. All'alba colli trovati sgombri vennero occupati più o meno contemporaneamente e io che mi ero avanzato fino al colle Rebbi Arieni, ne ricevevo avviso. Frattempo, ore 7, avendo notato verso sinistra, oltre colle Chidane Meret uno schioppettio piuttosto vivace, in direzione di Adua, feci avanzare di poco la colonna Dabormida e prendere posizione verso Mariam Sciauitù, per essere meglio in grado di appoggiare brigata Albertone e cooperare con essa insieme. Chiamai brigata Arimondi sul colle Rebbi Arieni. Poco dopo, ore 7.30 si intese cannone che tirava in direzione di Abba Garima ad una distanza da noi di forse cinque chilometri. La colonna di sinistra era impegnata ma assai più innanzi del prescritto.
Infatti un biglietto di Albertone ponevami subito corrente situazione, col dirmi che battaglione Turitto inviato dal colle in direzione verso Adua si era fortemente impegnato e che egli impegnava tutte le sue forze per disimpegnarlo.
Allora io ordinai alla brigata Arimondi di coronare prima coi bersaglieri poi col resto una altura antistante al colle Chidane Meret per sostenere Albertone e feci pure avanzare le due batterie a tiro rapido. Frattempo il combattimento continuava sulla cresta verso Adua assai intenso. Inviai ordini a Dabormida di appoggiare verso sinistra e di sostenere più direttamente Albertone. Ignoro se l'ordine sia giunto a destinazione. Grosse torme nemiche a destra e a sinistra sboccavano sulla cresta e costringevano la brigata Albertone a ripiegare dapprima ordinatamente; vi fu un momento di sosta; anzi da parte degli indigeni un accenno all'avanzata che io credetti attribuire alla brigata Dabormida i cui movimenti mi erano nascosti da un monte.
Frattanto le batterie a tiro rapido potevano aprire il fuoco sopra nemici a grandi frotte discendenti dalla cresta. Albertone ritirossi sotto posizione occupata da Arimondi che scende aspra e spinosa sul colle. Per rinforzare la quale venne pure battaglione Galliano già assegnato riserva. Ma sebbene il fuoco nemico fosse assai poco efficace, sebbene posizioni nostre fossero buone e dominanti, truppe si lasciarono impressionare da gruppi nemici che profittando angoli morti si riunivano e cercavano aggirarci: un gruppo che si era annidato sul monte indusse a rapido ripiegamento due battaglioni bersaglieri mentre anche i battaglioni del reggimento Brusati abbandonarono posizioni; anche battaglioni alpini della riserva non erano più in grado di opporre resistenza e venivano travolti dai fuggiaschi man mano che si presentavano.
I nemici frattanto con molta audacia salivano alla posizione e penetravano nelle nostre file sparando quasi a bruciapelo sugli ufficiali. Allora non valse nessun ritegno, nessun ordine per ritirata successiva. Invano ufficiali cercavano trattenere soldati su qualcuna delle successive posizioni, perché nemici irrompenti e pochi cavalieri Shoani scorrazzanti in basso bastarono a travolgere tutto. Allora cominciarono le vere perdite; soldati come pazzi gettavano fucili e munizioni per l'idea che se presi senza armi non sarebbero stati evirati, e quasi tutti gettarono viveri e mantelline. Invano io col generale Ellena, con i colonnelli Stevani e Brusati e Valenzano cercammo dirigere la corrente verso la sua base Saurià, tutti volgevano verso nord per la via più larga. A notte fermammo e cercammo di ordinare alla meglio una ritirata ma per un equivoco facile per quei sentieri la colonna si divise. Gli uni con i colonnelli Brusati e Stevani andarono verso Mai Haini, gli altri con me, Ellena, Valenzano vennero ad Adi Caièh. Non ho notizia della brigata Dabormida né dei generali Arimonti e Albertone: corrono voci più contrarie né posso farmi un concetto della gravità del disastro ma vedo impossibile riorganizzare battaglioni bianchi che hanno combattuto.
Truppe indigene hanno perso assai, sono disordinate e il loro morale deve essere scosso contegno bianchi, e tutti, ribelli e nemici interni, hanno ripreso animo. Parmi molto pericoloso ordinare sgombro forte Adigrat circondato dai ribelli con forte presidio invincibile. Stamane intendo andare Sagaineti-Asmara. Frattanto Lamberti che sarà domattina Asmara, tiene governo colonia e corrisponde con ministero”.
C’erano una serie di inesattezze e di ammissioni involontarie che qualsiasi osservatore della battaglia e i futuri giudici avrebbero facilmente individuato. Ma quello che colpiva tutti fu, naturalmente, la parte del resoconto in cui brutalmente il governatore accusava i suoi soldati di viltà. Era, prima che una meschinità a cui nessun generale dovrebbe abbassarsi (ma i nostri da Chrzanowski26 a Cadorna27 ne hanno una certa predisposizione), un falso. Gli episodi di crollo psicologico si erano avuti, ma solo nella caotica fase della ritirata. Durante la battaglia, tutti, inclusi i bersaglieri che Baratieri accusava di abbandono di posizioni buone e dominanti (non era vero come abbiamo visto), avevano tenuto bene il fuoco. Del telegramma Baratieri non si pentì mai. Nella sua autodifesa anzi aggiunge meschinità a meschinità. Sostenne infatti di aver scritto quelle parole perché sapeva che il telegramma era riservato e cifrato. Era il vecchio, collaudato sistema della doppia verità che il politico Baratieri mostrava di conoscere molto bene. E che gli consentiva di misurare col bilancino dell’opportunità la sua necessità di difendersi insudiciando la memoria delle vittime dei suoi errori.
Se sperava di strappare a Roma una dilazione del suo destino si sbagliava di grosso. Poche ore dopo avere ricevuto quell’incredibile telegramma, veniva pubblicato un decreto che, gettato in pasto all’opinione pubblica tumultuante, si sperava avrebbe placato le folle e l’opposizione che cominciava a individuare i responsabili del disastro. Lo scopo era di separare il destino del governatore da quello di coloro che intendevano continuare a gestire il potere come se nulla fosse successo.
Articolo unico
Il tenente generale Oreste Baratieri cessa le funzioni di governatore generale della colonia Eritrea. Il presente decreto avrà vigore dalla sua data e sarà registrato alla Corte dei conti. Dato a Roma il 3 marzo 1896.
Dall’estero, intanto, si infittiscono segnali scoraggianti e umilianti. In Russia si susseguono messe di ringraziamento per la vittoria abissina. In Austria si celebrano (e siamo alleati) le vendette per il 1866 e si tripudia per la nostra umiliazione, sui giornali tornano gli stereotipi sull’italiano imbelle e incapace. La Francia esulta apertamente. La solidarietà tra bianchi, che funzionava come una regola ferrea nelle faccende coloniali, per noi è stata sospesa. Solo la Germania ci restò vicina e la visita in Italia del Kaiser fu ostentatamente confermata.
Le reazioni dei partiti e degli uomini politici furono, come è tipico da noi, scomposte ed esagitate. I socialisti esultarono, perché era venuta in terra d'Africa la “batosta risolutiva” auspicata da Turati. Sui muri della caserma Sant'Ambrogio di Milano una mano scrisse: “Soldati, non andate al macello! Viva la bandiera rossa, viva Menelik!”. Esultarono anche i cattolici dalle pagine dell'Osservatore Romano e della Civiltà Cattolica.
Il radicale Imbriani e Felice Cavallotti premevano sul governo perché Baratieri non fosse giudicato da un Tribunale Militare, ma da un'Alta Corte di Giustizia formata da nove deputati. Lo stesso Imbriani il 30 novembre propose alla Camera che l'Italia si ritirasse definitivamente dall'Eritrea, ed Andrea Costa di rimando gridava in piena Aula: “Neanche più un soldo per l'Eritrea! Neanche più un soldo per l'Africa!”
A più di un anno di distanza, il 16 ottobre 1897, Alfredo Panzini, dalla Nuova Antologia, ricorreva invece al sarcasmo parafrasando l'esclamazione di Francesco I dopo la battaglia di Pavia: “Tutto è salvato fuorché l'onore!”
È però anche vero che l'onore non fu affatto perduto, come insinuava Panzini, o almeno fu perduto dai politici, ma non dai militari, poiché dalle inchieste successive ad Adua emerse il comportamento assolutamente coraggioso e impavido (per altro riconosciuto dallo stesso nemico) dei nostri soldati e dei nostri ufficiali. L'onore, tutto sommato, non fu perduto neppure dall'Italia nel suo complesso. La proposta Imbriani di abbandonare l'Eritrea fu respinta dalla Camera con centoventisei voti contrari e solo ventisei favorevoli. Ed un prestito nazionale aperto dal Governo per le spese sostenute nella guerra in Africa fu coperto ventidue volte più del richiesto!
E Crispi? Sperava, nonostante tutto di salvarsi. Al presidente del Senato che lo assedia Crispi concede un’altra manovra tattica. Il governo si dimetterà per impedire che la destra e la sinistra estrema votino coalizzate, ma solo per avere la possibilità di formare subito un nuovo gabinetto. Con tale spirito si reca dal re e gli offre le dimissioni. Si ritiene insostituibile ed è sicuro che Umberto I le respingerà. Il monarca, invece, depresso e terrorizzato dal rischio di dovere abdicare a causa dei tumulti di piazza, si era fatto i suoi calcoli e a sorpresa accoglie le dimissioni. Per alleviare la disperazione dell’uomo, pare gli offrì una grossa elargizione di denaro per i servizi resi (e non erano pochi) e l’amarezza del licenziamento. Lo stratagemma di pagare lo suggerì Farini28: “Provveda a lui in modo largo e generoso; non è difficile, egli è vecchio, ha perduto la clientela di avvocato per servire il paese... E l’offerta sia cospicua!” Altro segno di meschinità e dei modi con cui i Savoia gestivano i loro servitori.

L’ultimo amaro atto per il guerriero di Calatafimi fu comunicare, il 5 marzo, al Parlamento le sue dimissioni e quelle del governo. Il giubilo dei deputati, a parte una cinquantina che gli rimasero fedeli, fu esplosivo, stavolta sapevano che la caduta sarebbe stata definitiva. Subito dopo dalla sinistra cominciarono a partire cori di insulti impietosi. Come da italico costume l’accanimento contro l’uomo, ormai indifeso, continuò nel tempo a venire con rabbia tanto più avvelenata quanto più lo si era temuto e rispettato. Vennero rispolverati gli avanzi dello scandalo della banca romana, arrivarono mandati di comparizione per peculato, avvisi di interrogatori, tutto orchestrato dagli avversari politici che adesso non avevano più nulla da temere. Crispi si dimise anche da deputato, ma il 17 aprile del 1898 fu rieletto nel suo collegio di Palermo con 1.173 voti contro i soli 295 del suo avversario.
Fu sostituito da Di Rudinì, antiafricanista, il quale ordinò di firmare con Menelik una pace rassegnata e vergognosa: “Non vogliamo l’Etiopia neppure se ce la regalano” aveva telegrafato a Baldissera, ed era davvero un po’ troppo.
Poco dopo la battaglia, il 20 marzo, Menelik dovette ritirarsi dalla regione, sciogliere l'esercito e lasciare l'iniziativa agli italiani. Baldissera sbarcò il 4 marzo (soltanto tre giorni dopo l'eccidio) con gli aiuti tanto invocati da Baratieri, e furono gli italiani e non gli abissini a dare pietosa sepoltura alle ossa dei caduti; e se la situazione interna del Regno lo avesse consentito, sarebbero stati in grado di riprendere un'offensiva in grande stile già nell'estate del 1896. Invece, la sconfitta in un episodio d'armi segnò soprattutto la sconfitta di una linea politica e di un uomo, che non era Baratieri, ma Francesco Crispi. Così, il 18 maggio 1896, sembrò che l'Italia volesse sbarazzarsi persino del ricordo di tale disastro ed il tricolore fu ammainato nel forte di Adigrat che il generale Baldissera aveva riconquistato, benché non ci fosse alcun nemico a minacciarlo; e per soprammercato, Cassala, luogo di una nostra vittoria contro i dervisci, fu ceduta agli inglesi.
Commentò sulla Nuova Antologia il generale Domenico Primerano29: “Adua fu un doloroso episodio militare, ma non dell'importanza che gli si volle attribuire, e sarebbe stato riparabile all'indomani, se avessimo avuto la calma, la serenità e la fermezza di propositi che erano richieste in quel momento”. Identica era l'opinione del Times, che osservava: “Adua è un disastro militarmente inferiore all'apparenza, politicamente gravissimo”.
26 Wojciech Chrzanowski (Biskupice, 1793 – 1861) è stato un generale polacco. Carlo Alberto lo scelse come comandante dell'esercito del Regno di Sardegna nel 1849. Insieme a Gerolamo Ramorino fu accusato di tradimento. Ramorino fu giustiziato, mentre Chrzanowski riparò in Louisiana ed a Parigi, dove morì il 26 febbraio 1861.
27 Luigi Cadorna (Pallanza, 4 settembre 1850 – Bordighera, 21 dicembre 1928) è stato un generale e politico italiano. Comandante in capo dell’esercito italiano fino alla disfatta di Caporetto.
28 Domenico Farini, politico italiano (Montescudo, 1834 - Roma, 1900). Ufficiale del genio, prese parte alle campagne del 1859 e del 1866. Deputato di Ravenna dal 1864 al 1866, sedette a sinistra distinguendosi nelle discussioni di argomenti militari e dal 1878 fu presidente della Camera; creato senatore (1866), presiedette il Senato dal 1887 al 1898. Lasciò un Diario pubblicato in 2 volumi (1961-62), ricco di notizie sulla vita parlamentare italiana di fine secolo.
29 Domenico Primerano (Napoli, 29 marzo 1829 – Roma, 26 febbraio 1911) è stato un militare e politico italiano, capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano.
ADUA
Il generale Baldissera, il nuovo governatore, comunica a Baratieri il 6 marzo la sua sostituzione, il collocamento a riposo e l’ordine di recarsi a Massaua ad attendere disposizioni.
Colà viene posto agli arresti domiciliari (confortevoli) per circa due mesi, quando viene deciso di processarlo.
Lo scontro giudiziario fu preceduto da una complessa battaglia costituzionale. Baratieri infatti era un deputato e per processarlo occorreva il consenso dell’assemblea: nessun deputato, secondo la legge, poteva essere sottoposto a giudizio senza autorizzazione del Parlamento. D’altra parte non c’erano precedenti a cui ancorarsi. Dei due grandi sconfitti precedenti, Persano30 ammiraglio e senatore, era stato giudicato dal Senato; Ramorino31, il vinto di Novara, non essendo un deputato era stato condannato alla svelta a morte dai suoi colleghi.
Imbriani e Felice Cavallotti, due deputati radicali, premevano sul governo perché Baratieri non fosse giudicato da un Tribunale Militare, ma da un'Alta Corte di Giustizia formata da nove deputati, ma il nuovo ministro della Guerra, Ricotti, aveva altre idee. Per lui Baratieri era accusato di reati previsti dal codice penale militare, quindi dovevano giudicarlo dei militari.
La spuntò il Ricotti e non sarebbe potuta andare diversamente. In Italia un giudizio davanti alle Camere riunite si sarebbe trasformato in un processo alla classe politica del paese con effetti imprevedibili. Individuati in Crispi il colpevole politico ed in Baratieri quello militare, tutti gli altri, politici e militari, che pure avevano gravissime responsabilità, ne rimanevano fuori.
Il 10 maggio 1896, il generale Bacci, l’avvocato generale militare, spedisce alla Camera il ponderoso documento d’accusa dove si ricostruisce tutto l’accaduto. Trova moltissimi disposti a collaborare. La condanna di Baratieri significa anche l’assoluzione e l’oblio delle colpe altrettanto gravi di altri. Arimondi e Dabormida sottratti al giudizio da una morte eroica, prigioniero Albertone, Ellena una controfigura che non ha partecipato a nessuna decisione né alle fasi chiave della battaglia. Bacci aveva subito individuato i punti deboli della posizione del governatore: la scelta di attaccare e l’abbandono del comando.
Bacci propone alla Camera il rinvio a giudizio per questi due atti:
1) per motivi inescusabili si decise ad una azione contraria a tutti i principi dell’arte tecnica militare e che doveva portare, come portò, alla disfatta;
2) le conseguenze sarebbero state di gravità molto minore se, immemore dei propri doveri e della propria responsabilità, non si fosse ritirato quasi solo col capo di Stato maggiore senza dar ordine alcuno, senza prendere alcun provvedimento che la necessità delle circostanze imponevano dimodoché dalle 12 del primo marzo alla mattina del 3 il comando in capo rimase interamente abbandonato e il funzionamento ne fu assolutamente sospeso. Nelle ore del primo marzo e nel giorno successivo molti ufficiali e persino un impiegato civile di loro iniziativa trovarono modo di telegrafare [...] comunicando l’esito della battaglia e dando informazioni e consigli relativamente alla ritirata; e il comandante in capo al contrario si chiuse in tutto quel tempo nel più assoluto silenzio e solo alle 9 del 3 marzo redasse al ministero della Guerra un lungo telegramma nel quale senza misura di parole, senza dignità di linguaggio disse cose non necessarie, dannose, per di più non vere dimostrando di non conoscere la situazione, di non essersene fatto un giusto apprezzamento [...].
Era un’accusa che poteva costare la pena di morte. La commissione della Camera approvava all’unanimità. I deputati Sacchi e Imbriani, noti “estremisti”, chiedevano di allargare la ricerca alle responsabilità politiche del governo appena caduto. L’accorto Ricotti, che era il grande registra dell’operazione, rispose con un sibillino: “Se nel corso del processo emergeranno altre responsabilità si provvederà”.
Il processo iniziò il 5 giugno con il consueto sbarramento di eccezioni, di nullità e di vizi di forma che costituiscono il piatto forte del nostro diritto. Ci fu opposizione alla testimonianza da parte della difesa del generale Baldissera poiché “chi ha dato l’ordine di procedere non può apparire al processo”. Erano scrupoli legalistici pelosi; in realtà, Baldissera non si voleva chiamarlo perché conosceva molte realtà scomode della vicenda, a cominciare dai maneggi alle spalle di Baratieri e avrebbe potuto fare delle rivelazioni pericolose. Senza entrare nei dettagli, Baratieri, che evidentemente aveva avuto modo di pentirsi del famoso telegramma, si difende in maniera piatta, omette parecchio e fa cadere qua e là opportuni riconoscimenti al valore delle truppe. Così tra abissini sempre aggiranti (questa micidiale tattica nemica, stranamente fino ad allora sconosciuta) e messaggi mai pervenuti, in una maniera o nell’altra si poteva confutare l’accusa dell’improvvido attacco e la conseguente ritirata.
Il problema grande era la seconda accusa, quella dell’abbandono del posto di comando lasciando nei guai i soldati. Questa poteva essere letale, non perché il destino di questi ultimi, probabilmente, importasse più di tanto, ma perché è un epoca in cui il coraggio fisico è la prima e più rispettata virtù di un ufficiale. E qui il racconto zoppica. Cerca di salvarsi dicendo di avere perso la strada due volte essendo la guida indigena scomparsa (un personaggio fantomatico che non ha lasciato traccia). In conclusione il racconto faceva acqua da tutte le parti.
Incalzato dalle domande sulle comunicazioni tra lui e il governo, sul caso Baldissera, chiarimenti su orari e messaggi, cui, esitante, dovette ricorrere per rispondere, a scorciatoie dialettiche. Alla domanda di perché non diede l’ordine della ritirata, alla fine, non gli rimase che ammettere: “Non lo diedi”.
Baratieri ne uscì a pezzi.
L’analisi tecnica dello scontro definisce inconsulta la decisione di avanzare, ma attribuisce anche molta responsabilità a Albertone e Dabormida e sottolinea il disorientamento del Baratieri sopraffatto dagli eventi. Giudica incensurabile il comportamento personale del governatore, anzi si era fin troppo esposto ai pericoli, vista la carica che ricopriva, ma, poi, ritiene fondata l’imputazione di abbandono del posto di comando, solo che lo attribuisce a causa di forza maggiore e allo stato eccezionale delle cose. Infine parole molto dure per il pessimo funzionamento di tutto lo stato maggiore, da Valenzano a Salsa, accentuando i limiti di chi lo comandava.
Valenzano riferisce sulla riunione dei generali, sottolineando l’atteggiamento di Albertone per un’azione aggressiva. Albertone, dice Valenzano, chiese il permesso di raggiungere il Chidane Meret prima di Arimondi. A questo punto Baratieri chiede la parola per dire che egli negò il permesso. È la chiave della vicenda, evidenziare da parte dell’imputato, la “trappola” di Albertone ai suoi danni di costringerlo a battersi, che si incrocia con la sua decisione suicida di giocarsi tutto. Valenzano conferma. Tutto finisce lì.
Il 10 giugno, il tribunale che ha marciato a ritmo garibaldino come se avesse una gran fretta di concludere il doloroso capitolo, chiude l’escussione dei testi.
Era il momento delle arringhe. Il pubblico ministero confermò la fondatezza del primo capo d’accusa, attacco per motivi inescusabili, ma non il secondo, l’abbandono del comando. Era un bello sconto, visto che così Baratieri evitava la condanna a morte. Infatti la pena richiesta fu di dieci anni di carcere militare con pene accessorie.
Il clementissimo pubblico ministero, concludeva così l’arringa: “Pel paese e per l’esercito è minore il danno di avere un generale sfortunato ed incapace che di averlo colpevole”. E così il Bacci, forse per essere sicuro che questi austeri giurati immedagliati avessero ben capito cosa fare, arrivava perfino a formulare le ragioni politiche per l’assoluzione.
Che fosse stato combinato un grande accordo lo prova in maniera imbarazzante una lettera di Baratieri, datata 12 giugno, a una scrittrice, a cui dà appuntamento in luglio in Italia per un’intervista. Sicuro, dice, che sarà impossibile una condanna.
Non solo, al campo, gli ufficiali già commentavano la clamorosa assoluzione ancora prima che venisse letta la sentenza in aula.
La lettura della sentenza fu lunghissima, un quarto d’ora e così concludeva:
Considerando che di fronte ai fatti esposti non avrebbero fondamento le omissioni che gli furono ascritte le quali se a prima disamina possono assumere parvenza di reato, non lo conservano peraltro dopo le risultanze della pubblica discussione che le spogliano dell’estremo essenziale del proposito doloso e volontario e della negligenza del giudicabile, per queste considerazioni il tribunale esclude ogni responsabilità penale del generale Baratieri.
A questo punto finiva l’accordo tra l’ex governatore, i giudici e i padrini che da Roma avevano tirato i fili del processo. Ma non della sentenza. Irrompevano una serie di considerazioni aggiuntive che se erano irrilevanti da un punto di vista penale, davano al verdetto un esito totalmente diverso. Probabilmente appendice che certo non era conseguenza degli umori dei generali appartenenti alla giuria, a cui era affidato il compito di semplici cancellieri, ma che era stata scritta altrove:
Il Tribunale non può astenersi dal deplorare che la somma del comando, in una lotta così disuguale e in circostanze tanto difficili, fosse affidata ad un generale che si dimostrò tanto al di sotto delle esigenze della situazione. Per questi motivi il tribunale in rapporto ai reati ascritti al generale Oreste Baratieri nei sue sposti capi d’imputazione visti gli articoli 485 e 486 del codice penale militare, dichiara non farsi luogo a procedere contro il medesimo per inesistenza del reato e ne ordina l’immediato rilascio se non è per altra causa detenuto.
La sentenza fu accolta in silenzio, Baratieri alle parole che così brutalmente ne stigmatizzavano l’incompetenza ebbe un guizzo nervoso e uscì pallido dall’aula. Con un capolavoro giuridico era stato contemporaneamente assolto e condannato; anzi tanto più duramente condannato in quanto assolto. Tutte le colpe del disastro ricadevano sulla sua insufficienza, ne usciva assolto l’esercito e il paese, ma non mancava una opportuna pugnalata contro il vecchio governo crispino che aveva messo al comando un generale così incapace. A modo suo era un capolavoro politico.
Nonostante i meriti di guerra che Baratieri aveva colto nelle campagne contro i dervisci, e la grande popolarità che lo aveva circondato per le sue vittorie negli anni recenti, venne allontanato dall'esercito.
30 Il conte Carlo Pellion di Persano (Vercelli, 11 marzo 1806 – Torino, 28 luglio 1883) fu un ammiraglio e politico italiano, comandante della flotta italiana nella battaglia di Lissa. Persano annunciò sfacciatamente di aver sconfitto gli austriaci; per l'evento furono iniziati grandi festeggiamenti che durarono fino alla notizia del reale esito dello scontro. Sottoposto a giudizio davanti al Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, venne proclamata la sua colpevole inettitudine, tanto che fu privato del grado, delle decorazioni e radiato con disonore dalla Regia Marina.
31 Gerolamo Ramorino (Genova, 8 aprile 1792 – Torino, 22 maggio 1849) è stato un generale italiano. Gli venne attribuita la responsabilità per la disfatta di Novara. Venne condannato dalla corte marziale e fucilato nella Piazza d'Armi di Torino (il luogo della città dove si svolgevano tutte le parate militari) il 22 maggio 1849. Chiese, ed ottenne, di essere lui stesso a comandare il plotone di esecuzione.
ADUA
La battaglia agli italiani era costata, non c’è concordanza tra le stime, tra i 5.000 e i 7.000 morti (di cui 2.000 ascari) con circa 1.500 feriti. Da parte etiope si calcolano tra i 4.000 e i 7.000 morti con feriti tra gli 8.000 e i 10.000, di cui si suppone, visti i livelli della medicina in Etiopia, moltissimi saranno morti nei giorni successivi.
Furono catturati tra bianchi e indigeni circa 3.000 uomini.
Le prime ore dopo la battaglia, gli eccitati vincitori, sfuggiti al controllo dei loro capi si lasciarono andare a violenze e massacri. 230 tra ascari e italiani vennero giustiziati immediatamente.
La sorte peggiore toccò agli ascari. Quando il giorno dopo la battaglia Menelik raggiunse la città santa di Axum, la regina Taitù invocava che fossero massacrati. L’imperatore, cauto, decise di rimettere la decisione al metropolita Matteo, il quale stabilì che toccava loro l’atroce punizione dei traditori, il taglio della mano destra e del piede sinistro. Il supplizio riguardò 800 indigeni, gli ufficiali italiani dovettero assistere. Così gli ascari pagarono per la loro fedeltà, molti di loro avrebbero potuto, grazie alla loro velocità, fuggire, ma non lo fecero per rimanere ad assistere gli ufficiali. Nessuno gridò o chiese pietà. Circa la metà morirono per dissanguamento o infezione. I sopravvissuti si salvarono grazie all’intervento delle mogli e dei parenti che, sfidando l’ira degli abissini, li curarono e li riportarono nella colonia con un’incredibile anabasi di centinaia di chilometri.
Le evirazioni dei cadaveri ed anche dei vivi furono numerose32.
Nelle prime ore della prigionia quasi 2.000 italiani, tra cui un generale e molti ufficiali, ebbero destini diversi. Per il diritto abissino appartenevano a chi li aveva catturati e molti furono contesi, spesso selvaggiamente, tra i loro carcerieri che se ne disputavano la proprietà. La maggioranza subì percosse e violenze, molti però, si salvarono in virtù dei segni cristiani che portavano addosso, medagliette e croci.
Per loro fortuna la loro sorte era già stata decisa. Tutti i prigionieri italiani furono concentrati nel campo di Adua e nonostante la regina e alcuni ras avrebbero voluto procedere a un generale liberatorio massacro, la maggior parte di loro, in vista della possibilità di riscatti, per frenare una eventuale seconda invasione o come carta durante le trattative di pace, votarono contro questa soluzione.
Gli etiopi si misero alla ricerca di medici tra i prigionieri per curare i loro feriti. Molti italiani capirono che poteva essere la salvezza e alcuni che non lo erano dichiararono di esserlo poiché, comunque, tutti i bianchi avevano fama di essere grandi guaritori. Gli abissini rimasero impressionati dall’abilità di questi “medici”, tanto che vennero anche molte madri con i figli a farsi curare, portando polli, orzo, acqua pura. Parcelle che salvarono la vita a molti. Il tenente Cosimo Caruso, timoroso forse di procurare danni irreparabili, restò a mezza strada e si accontentò di dire che era un veterinario. Non gli andò male, perché divenne capo delle scuderie reali.
I prigionieri italiani furono poi portati ad Addis Abeba, un marcia lunghissima, durante la quale molti morirono di stenti. Nella capitale si ristabilirono quelle differenze tra ufficiali e soldati fatte di arroganza e prosopopea che erano una delle pecche del nostro esercito. La condizione di prigioniero avrebbe imposto un comportamento di dignità e di onore, invece alcuni ufficiali, in virtù del loro grado e di una più elevata classe sociale, accolti nelle case dei dignitari etiopi, quasi ostentavano la loro nuova condizione, ben vestiti, e nutriti, mentre frotte di soldati giravano per le strade laceri a mendicare un po’ di cibo.
Il tempo che passava migliorò la vita dei prigionieri, una delegazione della Croce Rossa portò cibo e vestiario.
Menelik comunque aveva bisogno di rimpinguare le casse del suo regno e voleva un riscatto. Il re d’Italia dovette bere l’amaro calice di questa umiliazione pagando la bella somma di dieci milioni di lire; pateticamente si pensò di salvare la faccia fingendo che si trattasse di un rimborso per le spese di mantenimento di alcuni mesi.
Mano a mano che si spegneva la ferita di Adua, almeno nei suoi aspetti più plateali, aumentava la tentazione di far finta che nulla fosse successo. I prigionieri e i reduci diventavano imbarazzanti e si cercava di dimenticare. Fu questa la ragione, ma non la giustificazione, del vergognoso trattamento che le autorità riservarono ai prigionieri. Matilde Serao33, sulle pagine del “Mattino” lo denunciò con veemenza.
Il 25 marzo, il vapore Sumatra che trasportava un primo contingente di sopravvissuti e feriti, fu fatto giungere a Napoli in piena notte in una zona remota del porto. I feriti furono trasportati su carretti attraverso strade secondarie negli ospedali. Insomma “la vergogna” fu nascosta con successo.

Per concludere restano da raccontare due episodi minori, ma che bene restituiscono il senso di quella tragedia.
L’antefatto del primo si svolse nel febbraio 1897, quando i prigionieri italiani ancora affollavano la corte del negus. Arrivò in visita privata il principe Enrico d’Orleans che era stato contrattato per scrivere una serie di articoli su “Le Figaro”. Incontrò il più illustre dei prigionieri italiani, il generale Albertone. I giornali italiani raccontavano che era guardato a vista per impedirgli di uccidersi, con gesto da antico romano. Esagerazioni. Partecipò, e senza farsi pregare, con altri ufficiali a un banchetto in cui gli abissini celebravano, in onore dell’alleato francese, la vittoria di Adua. Fu uno spettacolo penoso: alcuni dei nostri indossavano divise con bottoni che effigiavano l’imperatore; ci fu un brindisi al negus a cui Albertone si unì, pare, mormorando al principe con scarsa finezza: “È pura cortesia”. L’illustre ospite nei suoi articoli, dando una poco edificante descrizione del nostro comportamento, ci diede apertamente dei vigliacchi. Naturalmente ci fu la fila per sfidare a duello il francese, tanto che si dovette ricorrere all’estrazione tra tutti i pretendenti alla difesa dell’onore nazionale. Si dovettero fare tutti da parte quando si presentò il cugino del re, Vittorio Emanuele Savoia Aosta conte di Torino. Il francese apprese del duello quando la sua nave stava per attraccare a Marsiglia, dove infatti ricevette il guanto di sfida. Il principe non era ansiosissimo di battersi, ma ormai la notizia del duello si era diffusa fragorosamente in tutta Europa, facendone uno degli eventi mondani dell’anno. Il 12 agosto, all’alba, nei giardini del Bois des Maréchaux, a un’ora da Parigi, si svolse la tenzone. Il duello durò venticinque minuti e cinque assalti, poi il francese fu ferito (non gravemente), siccome era al “primo sangue”, il duello fu fermato per manifesta inferiorità del principe. Fu steso un verbale di ben quarantacinque pagine. L’esito sollevò in Italia grandi entusiasmi, quasi come se avesse pareggiato i conti per Adua.
32 Non ci sono in effetti prove definitive se queste evirazioni avvennero in così grande numero. Vero è che nella cultura di alcuni gruppi etnici della popolazione etiope esisteva questa pratica come prova del valore in battaglia di un guerriero.
33 Matilde Serao, scrittrice e giornalista (Patrasso 1856 - Napoli 1927). Nel 1884 sposò Edoardo Scarfoglio, col quale fondò il Corriere di Roma, poi il Corriere di Napoli (dove creò una rubrica mondana, “Api, mosconi e vespe”, che divenne presto famosa), e quindi Il Mattino, di cui fu condirettrice fino al 1904, quando si separò dal marito e fondò, sempre a Napoli, Il Giorno, che diresse fino alla morte (firmando anche con lo pseudonimo Gibus). Accanto a questa attività giornalistica, svolse anche opera di narratrice, che comprende oltre quaranta volumi fra romanzi e novelle.
ADUA
Un insuccesso non è un delitto. È dai loro sforzi che noi giudichiamo gli uomini e non dai risultati. (Lazare Carnot al generale Louis Hoche, dopo la sconfitta di Kaiserslauten)
“Oreste Baratieri generale delle milizie italiche noto al mondo per le sue fortunate imprese nelle campagne d’Africa e più per il subìto rovescio di fortuna che legò il suo nome a quello per l’Italia infelicissimo di Adua”. Povero Baratieri, l’epigrafe apposta sulla sua tomba, quando nel 1901 lo colse la morte, sembrava fatta apposta per aggirare con gli arzigogoli della retorica il peso di un imbarazzante ricordo. E invece no, cento anni dopo, nel 1996, ci fu chi volle trasformarlo in un simbolo permanente di sconfitta e disonore. Il governo etiopico lanciò un appello per trasformare l’anniversario di Adua, la più grande battaglia coloniale dell’Ottocento in “una festa della liberazione e dell’indipendenza di tutto il continente”. L’appello ebbe successo, sono cose che talvolta contano più del pane, il popolo etiope, dimentico dei problemi contingenti si unì in celebrazioni e feste, le quali si estesero a tutta l’Africa.
La storia del colonialismo registra sconfitte più o meno rovinose, ma la grande novità di Adua è che, per la prima volta, una nazione europea era stata costretta a rinunciare ai suoi piani e ad accettare la pace. Dietro Adua si celò anche una guerra diplomatica tra potenze europee. La Francia innanzitutto e in misura minore la Russia, armarono e guidarono il negus contro di noi. Parigi voleva colpirci per indebolire la Triplice Alleanza e la Germania.
Cosa resta oggi nella memoria italiana di quel macello africano? Quasi nulla. Forse qualche osteria di paese col nome Macallé. Adua non è entrata nemmeno nei modi di dire: infatti per indicare una sconfitta catastrofica (e non ci mancherebbero gli esempi) ci riferiamo a Caporetto.
Ad Adua morirono più italiani che in tutto il Risorgimento, epopea gloriosa, ma bonsai. Tuttavia quel numero equivaleva ai caduti di pochi minuti del Carso o del Piave durante la Grande Guerra. E in tali circostanze il paese rimase saldo. Eppure le conseguenze di Adua furono apocalittiche. Il paese sfiorò la rivoluzione, uno dei pochi grandi statisti (comunque la si pensi), Crispi, fu spazzato via, cadde un governo, vacillò la monarchia perché il re pensò seriamente di abdicare. Il sogno coloniale fu bloccato per decenni. Non fu una sconfitta, fu una crisi psicologica, un crollo morale; una nazione intera esibì senza pudore la propria umiliazione. Due anni prima, a Isandlwana, Sud Africa, gli inglesi subirono un disastro con molti meno morti, ma altrettanto brutale, ad opera degli zulu che, al contrario del negus non possedevano neppure un fucile, ma solo corte lance. Però, nessun ministero precipitò, le strade non si riempirono di cittadini imbufaliti decisi a mozzare la testa a ministri e generali, nessuno urlò “evviva” all’indirizzo del re degli zulu che aveva umiliato il loro esercito. Dopo pochi mesi gli sconfitti accolsero lo stesso nemico che veniva ad arrendersi. Perché da noi non fu così?
In quelle ventiquattro ore si sovrapposero e si scavalcarono due epoche diverse. Da un lato, c’era il vecchio mondo del Risorgimento con i suoi uomini scolpiti sulle lapidi, gli sforzi pazienti, le consorterie politiche che assomigliavano più alle clientele di Roma antica che ai partiti di oggi, i ministri che viaggiavano in seconda classe, le gloriose cariche di cavalleria, i nobili che pagavano il loro tributo di sangue. Era un mirabile edificio, che già in rovina dopo Porta Pia, aveva bisogno del restauro della retorica. Dall’altro, il mondo nuovo delle fabbriche, delle borghesie tremebonde o arroganti, delle plebi arrabbiate in cerca di nuovi profeti. Ci sono epoche in cui le élite si danno il cambio, talora con movimenti impercettibili, talaltra brutalmente. Adua scandì questo passaggio, una battaglia di poche ore, aveva svelato l’inadeguatezza di uomini e di una classe di potere carica delle medaglie del Risorgimento, che avevano fatto l’Italia disfacendo sé stessi. Non si inciampa in una disfatta per puro caso. Perdemmo l’innocenza che aveva guidato i padri fondatori. I vinti di Adua che tanto si erano prodigati, costruendo pazientemente il paese, avevano virtù che non bastavano più per accontentare i sogni di grandezza dei nuovi sudditi. Avevano fallito. I giornali crivellavano ogni giorno questa mediocrità e continuarono fino a quando il fascismo non la sostituì con una grandeur di cartapesta.
Crispi, che aveva superato tutte le bufere, finì pensionato e maledetto nella sua villa di Napoli. Il re, conservò il trono, ma fu assassinato quattro anni dopo, da un anarchico che voleva vendicare le vittime dei moti che Adua aveva provocato. Vittorio Emanuele III era già figlio di un’altra epoca, ma, a vedere i risultati, forse non migliore. Ora comandavano i Giolitti, dei pragmatici che non avevano lavorato con Cavour o marciato con Garibaldi, ma praticavano l’arte del compromesso. La sinistra di Cavallotti che difendeva, come un tribuno del popolo, i poveri e sfidava a duello gli avversari (ci rimise anche la pelle, e proprio per accuse legate ad Adua), lasciava il posto ai socialisti che parlavano a nome del proletariato, parola nuova che metteva paura.
L’esercito dei piemontesi con i bottoni lucenti si preparava ai tragici fasti in grigioverde nell’era industriale. Adua soffocò sul nascere la possibilità che l’Italia seppur in ritardo diventasse una potenza come quelle che all’epoca dominavano la scena mondiale. La vittoria nel Tigré ci avrebbe aperto la strada per Addis Abeba, cosa che avvenne quarant’anni più tardi, quando ormai era un’impresa anacronistica e il fascismo aveva definitivamente avvelenato la storia d’Italia. L’Etiopia non ci avrebbe resi più ricchi o meno poveri, perché non custodiva grandi ricchezze, ma ci avrebbe reso uguale agli altri, mettendoci al riparo dalla frustrazione, dall’insicurezza e dal rimorso, malattie letali nella storia dei popoli. Non è vero che colonie e democrazie non possano convivere, che, come dicevano i leninisti di un tempo, il veleno dell’imperialismo corrompe la madrepatria. Lo dimostrano le vicende di Inghilterra, Francia e Olanda. Forse coloro che poi alimenteranno le piazze del “maggio radioso34” e, peggio ancora, con la marcia su Roma, sarebbero diventati funzionari coloniali o avrebbero sfogato i loro umori in modeste imprese esotiche. Adua portò nell’umore, nella psicologia politica una serie di veleni che ebbero effetti incredibilmente nefasti: la vergogna di aver fallito la prova, il sordo rancore verso gli altri, per i grandi, che avevano deriso o favorito la nostra sconfitta, il desiderio di rivincita, l’attesa di un “uomo della provvidenza” a cui affidarsi purché ci assicurasse una vittoria. Il nostro nazionalismo si incarognì, divenne rancoroso, retorico e aggressivo. La sconfitta rilanciò l’irredentismo, la rabbia per il Risorgimento non ancora compiuto che si tradusse nel maggio del 1915 nel primo golpe di piazza della nostra storia, prova generale di altre marce negli anni a venire.
Per la prima volta una parte dell’opinione pubblica non si riconobbe più in chi la governava e le revocò il diritto di rappresentarla. Si gridò in piazza “viva Menelik”, quasi si preferisse il nemico che aveva massacrato i nostri soldati ai governanti di Roma. Venne meno il plebiscitario consenso all’unità nazionale. Nacquero due Italie che si guardavano in cagnesco, una frattura che non si è sanata neppure oggi.
Mussolini che da giovane si incatenava ai binari per impedire che le reclute partissero per l’Africa, astutamente capì che chi sanava quella ferita avrebbe avuto in mano un grande credito e infatti mai il fascismo ed il suo fondatore ebbero una popolarità così alta come quando l’Etiopia fu conquistata.

Chi piantò la bandiera ad Addis Abeba non sospettava che aveva posto le basi allo sviluppo di un’altra grande tragedia.
Nessuna battaglia ci somiglia di più nei difetti come quella di Adua. Il piano strategico difettoso fu dovuto alla nostra convinzione che l’impeto e la geniale improvvisazione possano compensare l’organizzazione, i mezzi, le retrovie e la logistica. Insomma l’estro vale quanto se non più dello studio e della preparazione metodica. L’intelligence di Menelik, un sovrano medioevale, funzionava meglio della nostra affidata a pomposi ufficiali di stato maggiore. Il negus aveva un reparto addetto alla sobillazione, noi credevamo in tutto quello che si diceva nei vicoli di Massaua.
Nella ricerca dei colpevoli si aprì la strada a un fenomeno destinato ad avere in ambito politico un duraturo successo: il vizio nazionale del capro espiatorio, dello scaricabarile nel quale si assommano, anche se sembra contrario ad ogni logica, la teorica volontà forcaiola e la pratica incapacità di punire. Il processo Baratieri, il quale mercanteggiò in cambio della rinuncia a mettere in piazza le responsabilità, pari alle sue, della classe politica, è la prova generale di altre sciagurate vicende dell’Italia monarchica e repubblicana. Adua non portò fortuna nemmeno al suo vincitore. Dopo di essa iniziò per Menelik un costante lento declino fisico, nelle pratiche di governo prevalse la volontà della regina Taitù e del suo partito che oggi potremmo definire ultranazionalista.
La regina, principale protagonista della nostra disfatta, ora ne raccoglieva i frutti. Il negus afflitto da nefrite e ossessionato dai medici di tutte le nazioni europee (eccetto noi) che volevano accaparrarsene i favori, riceveva le cure secondo il momentaneo gradimento politico della moglie. Accusata di una sorte di congiura dei medici, Taitù fece stampare un bollettino ufficioso sulla salute del monarca. Iniziativa straordinaria in un paese di analfabeti. I ras stufi di dipendere da quella donna prepotente e ambiziosa fecero pressione su Menelik che, nel 1909, dichiarò che non avendo figli maschi designava Ligg Jasù, figlio del ras Mikael come successore, il quale avrebbe governato sotto il controllo di un consiglio di reggenza visto che era un bambino. Solo a furia di pianti e di scene isteriche l’ex fiore d’Etiopia ottenne di rimanere a corte a fare da infermiera al marito, invece di finire in qualche remoto convento a meditare, mentre i suoi partigiani venivano imprigionati e dispersi.
Il 12 dicembre 1913 giunse in Europa la notizia che Menelik II, ormai l’ombra di sé stesso, era stato stroncato da un colpo apoplettico. Il nipote giovinetto salì al trono, ma presto si rivelò uno psicopatico crudele, rovinato dalla sifilide e dall’alcol. L’unità dell’Etiopia in pericolo fu salvata da Hailè Selassiè I. Era il figlio di ras Maconnen.
34 Furono una serie di manifestazioni pubbliche a favore della guerra che si intensificarono all'inizio di maggio 1915 dopo un discorso di Gabriele D'Annunzio a Genova. Seguirono diversi cortei in tutte le maggiori città che spesso sfociarono nella violenza. In quei giorni di maggio, soprannominato dagli stessi interventisti come “radioso”, nulla sembrava ormai ostacolare l'entrata in guerra. Le manifestazioni di piazza indussero i deputati, in maggioranza contrari alla guerra, a votarne l’entrata a fianco di Inghilterra, Francia e Russia.
Pubblicato il 02/01/2014